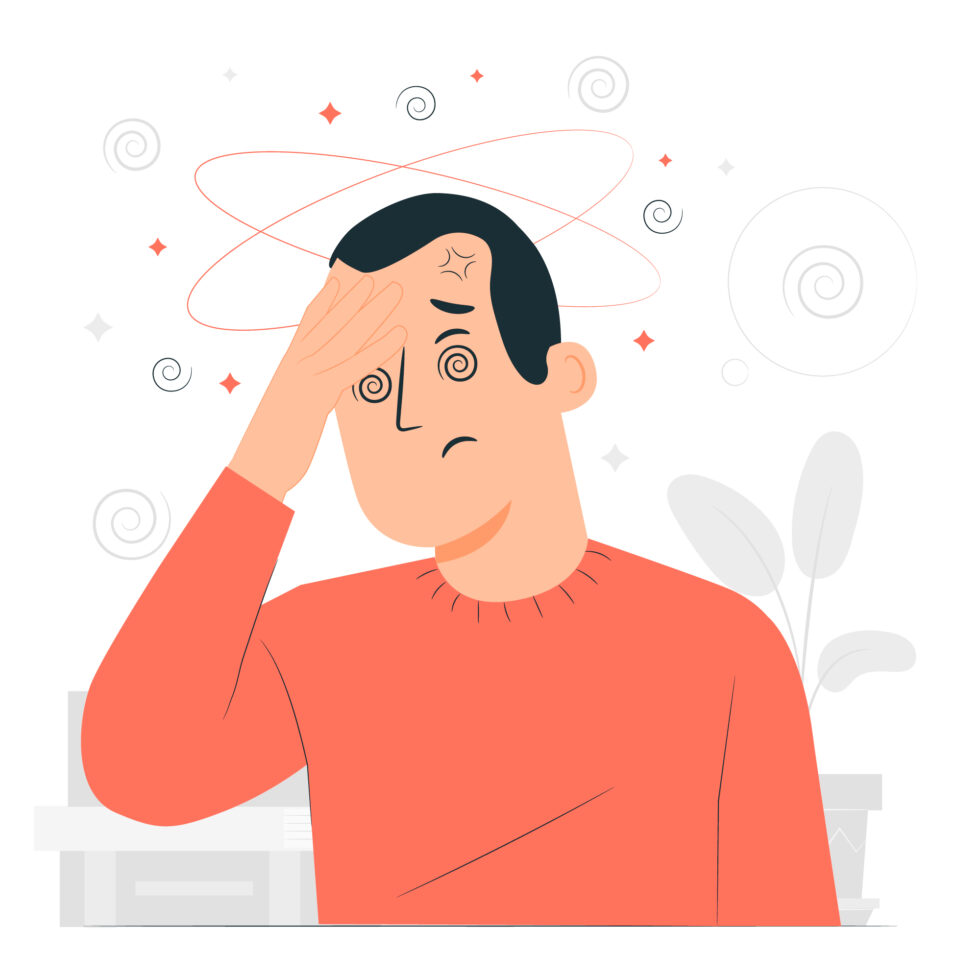La cleptomania (dal greco: κλεπτειν, “rubare” e µαµια, “mania”) è caratterizzata dalla ricorrente incapacità di resistere all’impulso di rubare oggetti che non hanno utilità personale o valore commerciale.
Il furto non è compiuto né per vendetta, né per rabbia, né dietro ad un delirio o ad un’allucinazione, ma per l’incapacità a resistere ad un desiderio impellente. Il furto non è attribuibile a un disturbo del comportamento, episodi maniacali o disturbi della personalità.
In genere, gli oggetti rubati sono di scarso valore per la Persona, tanto da essere ceduti ad altri o gettati. Più raramente può anche conservali e restituirli di nascosto.
Spesso il gesto è seguito da profondi sensi di colpa, tristezza, auto disapprovazione e ansia.
Tutti i buoni propositi di non ripetere il gesto vengono meno e il solito ciclo si ripete senza che la Persona cleptomane possa interromperlo, se non astenendosi da frequentare tutti i luoghi ove possa essere indotta in tentazione (es. negozi, supermercati, etc.).
Solitamente, il cleptomane non programma il furto, lo mette in atto da solo senza la complicità o l’assistenza di nessuno, prestando attenzione a non essere arrestato.
L’atto di rubare è preceduto da una sensazione di crescente tensione accompagnata da piacere, gratificazione e sollievo in seguito al furto.
La Persona si rende conto dell’insensatezza dell’atto ed in seguito a ciò può esperire uno stato di depressione e un forte senso di colpa.
Il cleptomane vive relazioni familiari, professionali e personali molto complesse e talvolta incorre in problematiche legali derivate dalle sue azioni, incorrendo anche in stati detentivi.
Il sintomo può emergere nella fanciullezza, nella adolescenza o nell’età adulta e in casi rari nella tarda età adulta. La patologia sembra essere più frequente tra le donne rispetto agli uomini, così come accade per lo shopping compulsivo (shopping addiction) con il quale la cleptomania ha molte affinità.
La cleptomania può subire delle evoluzioni e dei cambiamenti, per esempio le Persone possono rubare sporadicamente alternando lunghi periodi di remissione, oppure la patologia può essere cronica.
La cleptomania si può manifestare in concomitanza di altri disturbi: depressione maggiore, bulimia e disturbo ossessivo compulsivo.
Questa condizione patologica è stata osservata frequentemente anche in Persone con disturbi da abuso di sostanze stupefacenti ed alcol. Altre condizioni associate alla cleptomania comprendono disturbi d’ansia e ansia sociale.
Come insorge la cleptomania
Le cause che possono condurre alla cleptomania sono per certi versi sconosciute.
La psichiatria definisce la cleptomania come una forma ossessiva del pensiero, in quanto l’idea del furto e del suo compimento pervade la mente, impedendo qualsiasi altro tipo di attività.
L’atto di rubare produce un effetto emozionale che supera ampiamente qualunque tentativo razionale di frenarsi, al punto da non considerarne neppure le conseguenze. La gratificazione che deriva dal furto diventa irrinunciabile per il cleptomane, che tende a ripetere nuovamente il gesto.
Secondo un’interpretazione psicoanalitica, il furto servirebbe a risolvere fenomeni depressivi e stati di angoscia dovuti a un inconscio senso di colpa. La spiegazione della cleptomania andrebbe ricercata nel desiderio della punizione come atto compensatorio al proprio comportamento. L’obiettivo del cleptomane sarebbe la mortificazione, l’umiliazione e l’espiazione di una pena, da cui dipende il raggiungimento di una temporanea serenità.
Intervento terapeutico
La diagnosi di cleptomania non è semplice, in quanto la maggioranza delle persone che esprimono questo disturbo tende a non ricercare aiuto per risolvere il problema. La condizione è spesso diagnosticata quando le Persone si rivolgono al professionista per altri motivi, ad esempio uno stato depressivo o disturbi del comportamento alimentare o instabilità emotiva, nonché successiva a procedimenti legali nei quali la Persona è imputata.
La spiegazione che i cleptomani adducono per giustificare il loro comportamento è, di solito, una mancanza di mezzi di sussistenza o un’insoddisfazione personale. L’osservazione psicologica può riscontrare conflitti relazionali o fattori che causano eccessivo stress.
Gli interventi terapeutici per la Cleptomania si prefiggono di accrescere la consapevolezza del Paziente circa il proprio disturbo e promuovere la compliance, nel caso in cui sia necessario, al trattamento farmacologico.
L’intervento psicoterapeutico si pone l’obiettivo di:
- Approfondire la storia di vita della Persona, la storia del sintomo e il significato dello stesso all’interno dei propri mondi relazionali.
- Aumentare la consapevolezza della Persona circa la propria condotta.
- Individuare e ristrutturare i pensieri e le emozioni ricorrenti, gli schemi fissi di ragionamento e di interpretazione della realtà, che sono concomitanti alle reazioni fisiche, emotive e comportamentali relative all’espressione del sintomo.
- Ridurre la sintomatologia.
- Potenziare l’autostima e il senso di Sé.
- Ridurre i livelli di stress e di disagio emotivo – cognitivo – relazionale attivati dal disturbo.
- Sviluppare comportamenti alternativi per la gestione delle emozioni intense.
- Recuperare una maggiore efficienza e autoefficacia in campo sociale, lavorativo o scolastico e relazionale.
- Potenziare le abilità di coping per il fronteggiamento dello stress e dell’ansia.