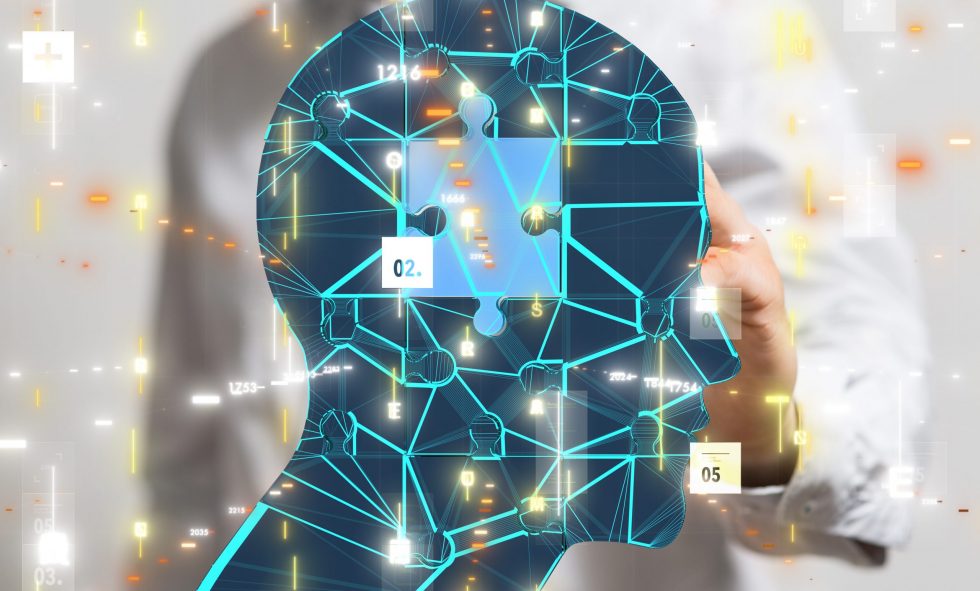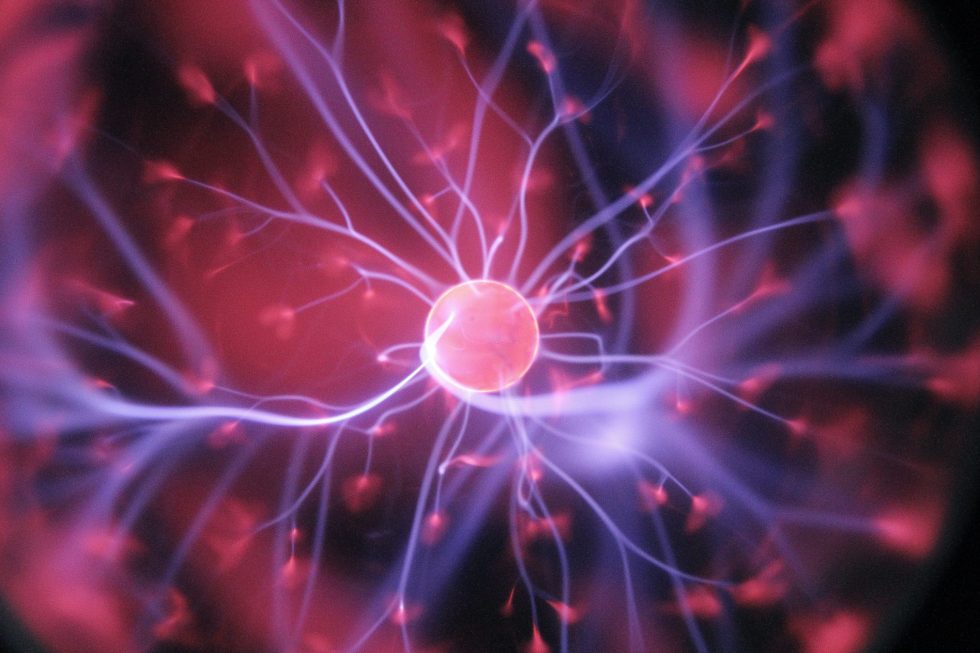Le funzioni cognitive, centrali nella psicologia e nelle neuroscienze, comprendono un insieme di processi mentali complessi che ci permettono di percepire, pensare, ricordare e interagire con il nostro ambiente. Queste funzioni svolgono un ruolo fondamentale per il modo in cui elaboriamo le informazioni e prendiamo le decisioni. Non sono compartimenti stagni, ma dei processi strettamente collegati e interconnessi che operano continuamente per garantire che tutto funzioni, attivando diverse parti del nostro cervello e formando mappe cognitive che ci permettono di conoscere e adattarci al mondo che ci circonda.
La memoria è la capacità di immagazzinare le informazioni che derivano dall’esperienza.
Il sistema della memoria è costituito da tre fasi: la codifica che permette di far entrare l’informazione sensoriale nel sistema di memoria, l’immagazzinamento che è la capacità di mantenere nel tempo l’informazione che abbiamo codificato e il recupero che ci permette di recuperare l’informazione codificata e di utilizzarla a seconda delle necessità, in modo consapevole e inconsapevole.
La funzione tramite cui si esprime la memoria è il ricordo, la cui diminuzione e scomparsa determina l’oblio. La presenza dei ricordi fa supporre che a livello cerebrale si verifichi una duratura trasformazione delle informazioni, che prevede il deposito della traccia mnestica nelle cellule neuronali sotto forma di particolari molecole di RNA (acido ribonucleico). Inibendo la sintesi dell’RNA, infatti, le informazioni non vengono memorizzate a lungo termine. La memoria è una funzione globale che è connessa a varie altre funzioni cognitive e dipende molto dagli stati interni dell’individuo.
Tipologie di memoria
- La memoria a lungo termine (MLT) ha capacità illimitate e può conservare informazioni per periodi molti lunghi.
Nella MLT rientra la memoria dichiarativa che riguarda la rievocazione consapevole di informazioni verbali e non verbali. Questa si suddivide a sua volta in memoria episodica che racchiude tutte le informazioni relative alla vita passata (memoria autobiografica) e alla vita futura (memoria prospettica) e in memoria semantica che permette di dare un significato alle conoscenze che possediamo sul mondo. Un’altra dimensione della MLT è la memoria procedurale, è costituita da conoscenze che non sono esprimibili a parole e che riguardano quindi il saper fare qualcosa, come andare in bicicletta o guidare la macchina.
- Attraverso la memoria a breve termine (MBT) l’informazione passa in un magazzino temporaneo con capacità limitata e codice fonologico in grado di conservarla per circa 30 secondi. Se l’informazione sosta per un tempo sufficiente in questo magazzino passa al magazzino della memoria a lungo termine. Si può pensare ad una libreria a ripiani, nella quale le informazioni nuove occupano il primo ripiano e spingono le altre informazioni in posizioni sempre più esterne.
- La memoria di lavoro è l’abilità che consente alla persona di ritenere le informazioni in memoria, compiere delle trasformazioni su di esse e restituirle in un secondo momento con lo scopo di raggiungere un determinato obiettivo.
- Si parla di memoria sensoriale quando si è in presenza di un processo in grado di memorizzare informazioni sensoriali: uditive, visive, tattili, olfattive e gustative per la durata di pochi secondi o millisecondi. Ad esempio, se fissiamo una luce e chiudiamo gli occhi ci sembrerà per pochi istanti di vedere ancora la luce. Oltre a questa memoria sensoriale visiva a brevissimo termine (memoria iconica), esiste una memoria sensoriale uditiva a brevissimo termine (memoria ecoica) ed una memoria tattile (memoria aptica).
L’attenzione svolge un ruolo cruciale nel selezionare le informazioni rilevanti dal flusso costante di stimoli. L’attenzione, quindi, rappresenta una componente fondamentale per interagire con l’ambiente circostante, controllando che anche gli altri processi cognitivi lavorino adeguatamente.
In neuropsicologia gli aspetti che caratterizzano l’attenzione sono:
- rimanere concentrati durante compiti prolungati nel tempo (attenzione sostenuta);
- focalizzarsi su più stimoli contemporaneamente (attenzione divisa);
- ignorare gli stimoli non rilevanti (attenzione selettiva)
- compiere shifting da un compito all’altro, ovvero alternare l’attenzione tra due focus cui non bisogna prestare attenzione contemporaneamente (attenzione alternata).
A livello cerebrale, i meccanismi implicati nella selezione delle informazioni riguardano sia il livello sottocorticale sia il livello corticale, soprattutto per quanto riguarda l’attenzione selettiva e ciò sottolinea come questo processo sia interconnesso con le altre funzioni cognitive.
Il processo di selezione di informazione è molto di più del semplice percepire. Prestare attenzione a qualcosa consiste nel prendere possesso da parte della mente, in chiara e vivida forma, di uno dei tanti oggetti possibili. Il grado di attenzione dipende dal livello di attivazione dell’organismo che a sua volta dipende sia dalle condizioni interne che dagli stimoli esterni.
Quando si parla di attenzione si intende una vasta gamma di processi: l’attenzione può essere automatica (esogena o bottom up) o volontaria (endogena o top down) e può essere diretta verso stimoli esterni o stimoli interni, come quando pensiamo a qualche ricordo o facciamo qualche calcolo. Inoltre, può essere covert, cioè senza movimenti oculari oppure overt con spostamenti oculari.
Gli stimoli intensi suscitano attenzione, selezionando le informazioni in ingresso in base alla loro rilevanza biologica, emotiva o psicologica. Rappresentando il processo di selezione di informazioni, l’attenzione è un processo cognitivo molto significativo.
La ricerca in psicologia cognitiva ha dimostrato che la nostra capacità di attenzione è limitata, ma può essere migliorata attraverso tecniche di concentrazione e focalizzazione.
La percezione comprende il modo in cui il nostro cervello elabora le informazioni sensoriali provenienti dall’ambiente. Vista, udito, tatto, gusto e olfatto sono tutti canali sensoriali che contribuiscono alla nostra percezione del mondo.
La percezione è un processo automatico che favorisce la sintesi e l’organizzazione delle sensazioni, assumendo forme dotate di significato. La percezione organizza ed elabora i dati sensoriali in modo che questi vengano elaborati in processi cognitivi più elevati, come la categorizzazione e l’identificazione di oggetti. I primi processi sono impegnati nella ricezione dal mondo fisico delle varie forme di energia (luminosa, sonora, tattile, gustativa, olfattiva) e nella trasduzione di questa energia in un segnale nervoso. Se il potenziale dello stimolo raggiunge la soglia individuale dell’organo di senso si trasforma in potenziale d’azione (sensazione). Successivamente, queste informazioni proseguono il percorso, entrando in connessione con altre funzioni cognitive come la memoria e le abilità spaziali, permettendo così un’analisi più profonda dello stimolo.
Il processo psicofisico della percezione può essere descritto così: lo stimolo è composto dagli oggetti fisici con capacità intrinseche capaci di impressionare le vie nervose. I percetti hanno il compito di codificare le informazioni provenienti dagli altri processi per rappresentare meglio lo stimolo. Ogni animale/ogni persona interagisce con un determinato ambiente sensoriale ed è quindi sensibile ad una ristretta gamma di segnali. Il segnale che raggiunge la corteccia cerebrale attiva neuroni che sono sensibili a determinate caratteristiche fisiche o cognitive ed in questo modo si ha la percezione che è quindi determinata da: input sensoriale, organizzazione del sistema nervoso ed esperienze passate.
Il linguaggio è uno strumento con duplice funzione:
- comunicativa, in quanto ci consente di trasmettere e ricevere le informazioni.
- conoscitiva, in quanto ci consente di conoscere il mondo.
E’ un sistema di comunicazione aperto, perché crea da un numero limitato di elementi messaggi nuovi.
Il linguaggio verbale consiste nella competenza di associare suoni e significati mediante regole grammaticali che variano a seconda della lingua ed è lo strumento cognitivo che più caratterizza la specie umana.
Il linguaggio è contraddistinto da diverse componenti, organizzate in modo gerarchico e ognuna di queste può essere valutata in comprensione e produzione di tutte queste parti:
- fonetica: studia la produzione e la percezione di suoni linguistici (foni) e le loro caratteristiche;
- fonologia: studia come i suoni linguistici funzionano all’interno di una certa lingua, ovvero come si organizzano le unità distinte di suono (fonemi);
- semantica: studia il significato delle parole (semantica lessicale), degli insiemi delle parole, delle frasi (semantica frasale) e dei testi;
- morfologia: studia la parte della grammatica e della linguistica che ha per oggetto lo studio della struttura grammaticale delle parole e ne stabilisce la classificazione e l’appartenenza a determinate categorie (nome, pronome, verbo, aggettivo) e le forme della flessione (coniugazione, declinazione). Indaga anche i meccanismi secondo i quali le unità portatrici di significati semplici si organizzano in significati più complessi, ovvero le parole;
- sintassi: studia le regole e le relazioni modulari che stabiliscono il posto che le parole occupano all’interno di una frase e come le frasi si dispongano a formare un periodo;
- lessicologia: studia la strutturazione del lessico;
- pragmatica: studia l’uso della lingua come azione, ovvero osserva come e per quali scopi la lingua viene utilizzata, di come il contesto influisca sull’interpretazione dei significati.
A livello anatomico, le aree cerebrali principalmente coinvolte nella produzione di parole e nella comprensione di ciò che si ascolta sono rispettivamente l’area di Broca e l’area di Wernicke, le quali comunicano in maniera continua, permettendoci di affrontare una conversazione. L’informazione non rimane arginata in queste aree cerebrali, ma transita all’interno dei diversi circuiti neurali per consentire un’elaborazione più profonda dello stimolo verbale. Una lesione o disfunzione cerebrale di queste aree può colpire selettivamente una funzione cognitiva, parte di essa oppure coinvolgere aree più vaste invalidando il processo comunicativo.
Le funzioni esecutive consistono in una serie di abilità cognitive necessarie per effettuare un comportamento finalizzato, indipendente e adattativo. Sono dei processi cognitivi superiori che supervisionano, direzionano e controllano le altre funzioni cognitive che intervengono nella formazione di comportamenti diretti a uno scopo.
Esistono:
- funzioni esecutive “calde” che comprendono tutti quei processi di controllo che operano in condizioni di elevata partecipazione emotivo – motivazionale, come la regolazione delle emozioni e del comportamento;
- funzioni esecutive “fredde” chiamate in causa quando è necessario risolvere problemi astratti e decontestualizzati. Sono di estrema importanza per inibire, cambiare, pianificare ed eseguire determinati schemi comportamentali.
Le funzioni esecutive sono una sorta di direttore d’orchestra del cervello, comprendono, infatti, un insieme di abilità mentali superiori che aiutano a pianificare, prendere decisioni, risolvere problemi e controllare gli impulsi. Queste abilità fondamentali permettono di vivere la quotidianità in modo adattivo. Le funzioni esecutive comprendono elementi quali la flessibilità cognitiva, la memoria di lavoro, l’autocontrollo e la gestione del tempo. Sono essenziali per raggiungere gli obiettivi, elaborare le informazioni in modo efficace, agire in modo equilibrato in diverse situazioni, tra le quali quelle inerenti all’interazione sociale.
Le funzioni prassiche riguardano il movimento e lo spazio.
Gli atti motori, infatti, ci permettono di spostare il nostro corpo nello spazio, mettendolo in relazione con il mondo esterno.
Le funzioni prassiche sono le abilità che consentono a una persona di coordinare e pianificare i movimenti del proprio corpo per eseguire compiti motori complessi ed agire nell’ambiente. Queste abilità sono essenziali per le attività quotidiane come la scrittura, l’uso di utensili da cucina, la guida e la partecipazione a sport. Questo include la capacità di imparare nuove abilità motorie, come imparare a suonare uno strumento musicale o a guidare un’automobile. Le abilità prassiche coinvolgono anche la capacità di adattarsi alle nuove situazioni e di utilizzare la propria esperienza motoria per affrontare nuove sfide.
I sistemi motori guidano ed istruiscono gli atti motori e ricevono, integrandole, le informazioni dai sistemi sensoriali. I segnali elettrici vengono trasmessi attraverso comandi motori alla muscolatura scheletrica che va ad eseguire il movimento. I sistemi motori ricevono anche dal sistema propriocettivo che dà info sulla lunghezza e tensione dei muscoli e sullo stato delle articolazioni.
I centri superiori sono responsabili della programmazione e dei comandi per il movimento volontario, mentre ai centri inferiori è lasciata l’organizzazione dei movimenti riflessi. La via finale comune si costituisce a livello dei motoneuroni midollari. I sistemi sono il midollo spinale (1° livello) tronco dell’encefalo (2° livello), corteccia motoria primaria (3° livello), corteccia premotoria (4° livello), A questi si aggiungono la corteccia parietale, i nuclei della base ed il cervelletto.
Le funzioni prassiche sono poco conosciute, perché un loro disturbo si evidenzia comunemente solo quando, a seguito di una lesione cerebrale o di patologia neurodegenerativa, si chiede ad una persona di compiere un gesto con consapevolezza. La persona con disturbo prassico perde la capacità di eseguire gesti ed utilizzare oggetti o strumenti in assenza di problemi di forza o di coordinazione, mentre nella normalità un gesto abituale è compiuto senza attenzione, né consapevolezza. Uno degli esempi più comuni è la guida di un’auto: inizialmente bisogna esercitare un grande controllo per imparare i gesti in maniera corretta e non arrecare danni, successivamente, con la pratica, le sequenze motorie diventano automatiche e il controllo si riduce.
In sintesi, le abilità prassiche sono le abilità che consentono a una persona di coordinare i movimenti del proprio corpo per eseguire compiti motori complessi. Queste abilità sono essenziali per le attività quotidiane e sono influenzate da molti fattori, tra cui l’ereditarietà, l’esperienza motoria e l’ambiente.
Perché allenare le funzioni cognitive?
Le funzioni cognitive non sono solo processi passivi che avvengono nel nostro cervello, esse possono anche essere migliorate e rafforzate attraverso un allenamento mentale.
Il training cognitivo è un processo che utilizza una serie di esercizi strutturati e ripetitivi finalizzati a migliorare, potenziare, preservare o riabilitare le funzioni cognitive di una Persona migliorandone la qualità di vita.