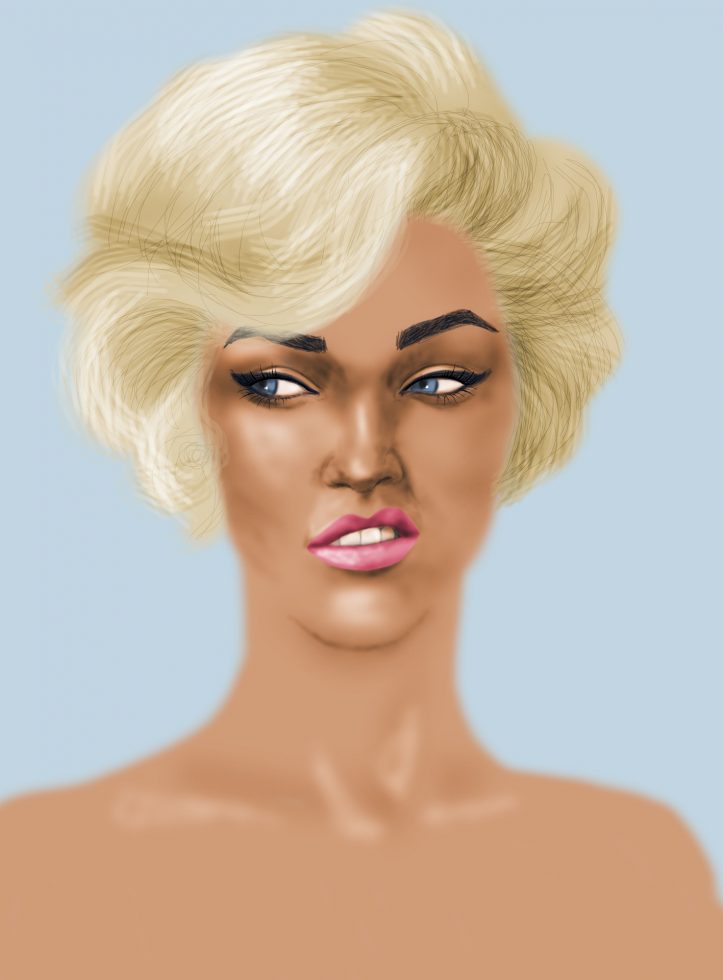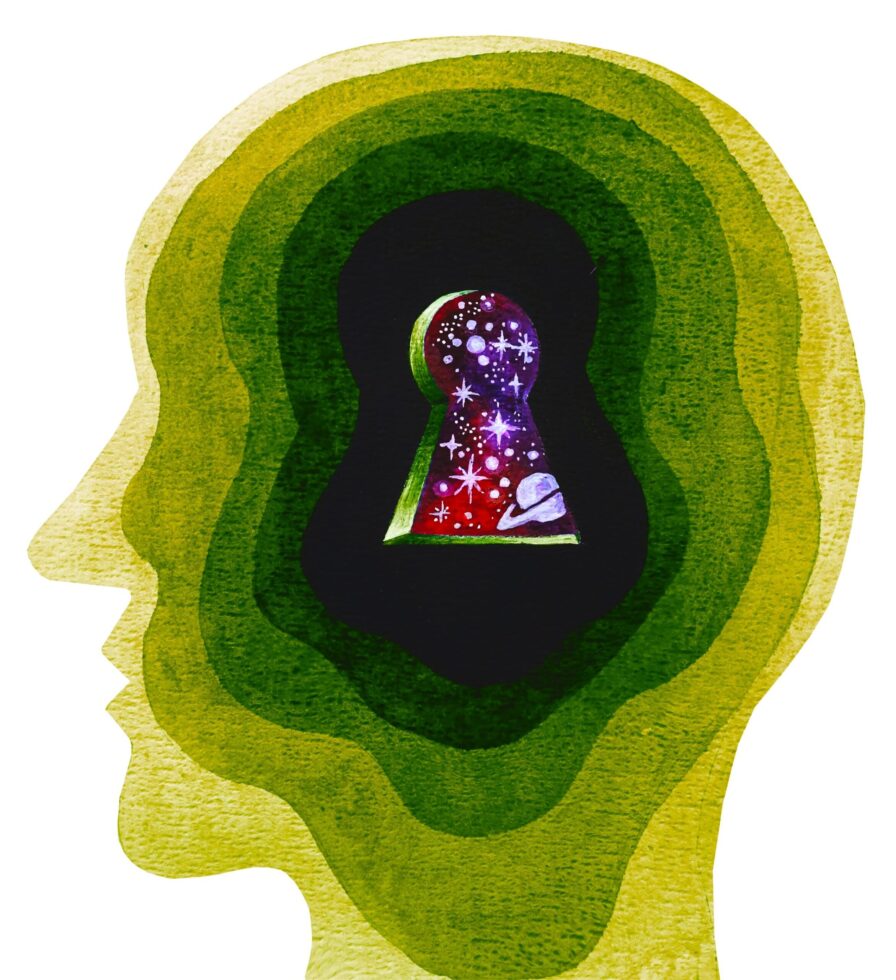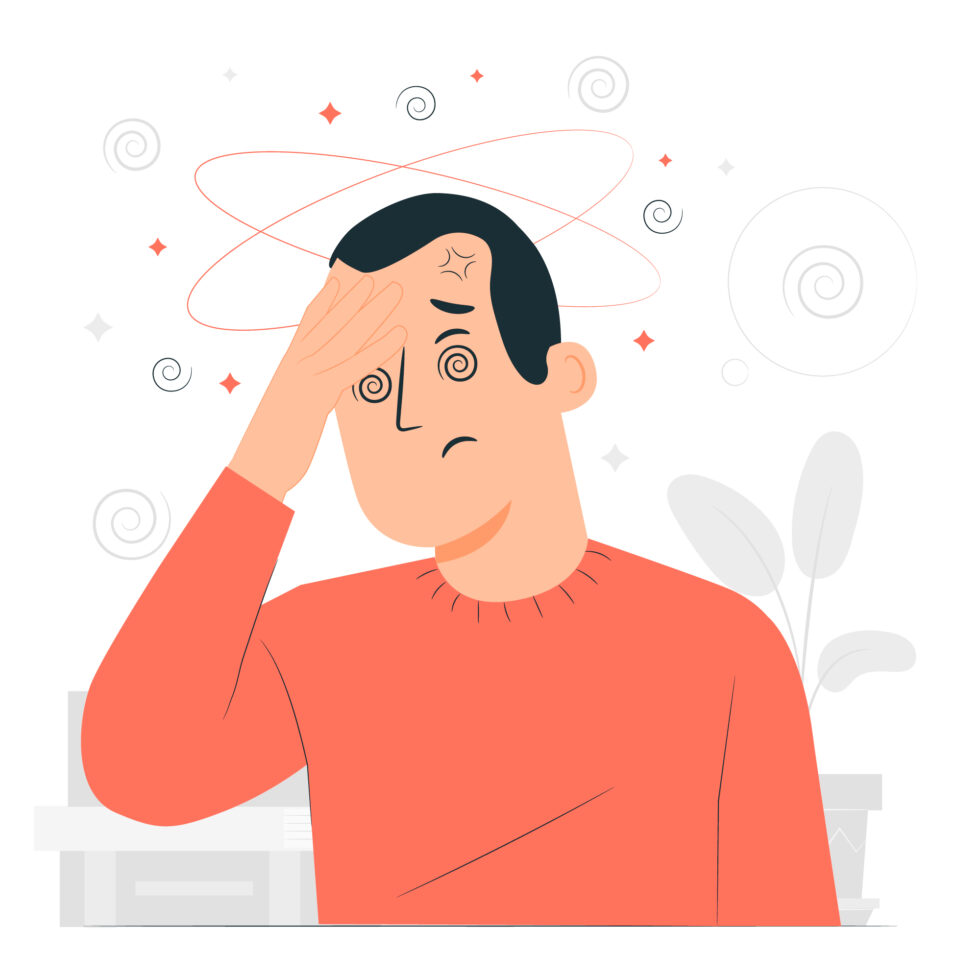Il disgusto è un’emozione primaria che fa parte di quelle risposte emotive innate come gioia, rabbia, paura, tristezza che hanno un ruolo significativo ai fini dell’ADATTAMENTO e della SOPRAVVIVENZA dell’uomo.
Il disgusto è un’emozione attivata in risposta a stimoli sgradevoli e potenzialmente nocivi, è un’emozione che ha uno scopo di difenderci da sostanze potenzialmente velenose e pericolose per la nostra sopravvivenza.
Secondo la prospettiva psicoevoluzionistica, che si sviluppa a partire dagli storici lavori di Charles Darwin (1872) condivisi nel libro “L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali”, il disgusto è definito come “qualcosa di nauseante in relazione primariamente al senso del gusto”, sia esperito sul momento che ricordato. Possiamo quindi definire il disgusto come una reazione emozionale di difesa finalizzata ad impedire l’assunzione di sostanze potenzialmente nocive attraverso la bocca.
La reazione di avversione/rigetto/repulsione che il disgusto provoca ha dunque un importante FUNZIONE ADATTIVA.
Gli psicologi americani Paul Rozin e April Fallon (1997) sono fra coloro che hanno studiato più approfonditamente la psicologia del disgusto. Questa emozione ha in origine una connotazione spiccatamente orale poiché consiste essenzialmente in un’avversione/rifiuto a certe categorie di sapori (es. amaro). Tale risposta ha un indubbio significato adattivo in quanto permette ai mammiferi di distinguere cibi pericolosi da cibi commestibili.
Anche per noi esseri umani il disgusto riveste una funzione importante estendendosi tuttavia a molte altre categorie di stimoli in grado di provocare lo stesso tipo di reazione avversativa.
Non solo i cibi, dunque, possono provocare disgusto anche certi animali, il contagio con certe malattie, il contatto con la morte, situazioni di scarsa igiene, etc. Per noi esseri umani, dunque, il disgusto può essere provocato da tutta una serie di stimoli non necessariamente alimentari o connessi ad una minaccia fisica.
La molteplicità degli stimoli in grado di provocare disgusto negli esseri umani sembra sia legata all’importanza che questa emozione riveste non soltanto per la sopravvivenza fisica, ma anche per il FUNZIONAMENTO SOCIALE.
Secondo Rozin e Fallon, questa emozione sarebbe connessa ad un più generale pericolo di contaminazione del Sé: se una sostanza disgustosa supera le barriere del corpo (ad es. mangiamo un cibo avariato, veniamo punti da un insetto, entriamo in contatto con materiale fecale, etc.) quello che rischiamo non è solo la nostra eventuale incolumità fisica, ma anche uno svilimento della nostra dignità.
Sembra che assimilare un alimento, avvicinarsi ad un oggetto o ad un dato elemento, implica assumerne in qualche modo le sue caratteristiche. In tal senso, siamo istintivamente portati a rifiutare il contatto diretto con tutto ciò che va contro le norme di igiene, decoro e dignità che ci caratterizzano come esseri umani e che fondano appunto il nostro sistema sociale.
E’ possibile aggiungere che, in quanto emozione, il disgusto ha una componente di stato, ossia l’attivazione fisiologia in presenza di uno stimolo disgustoso e una componente di tratto, ossia la tendenza relativamente stabile che determina in che grado le persone provano disgusto in contesti e situazioni differenti.
Si può anche distinguere tra propensione al disgusto e sensibilità al disgusto: con la prima tipologia s’intende la tendenza a provare disgusto con maggiore frequenza ed intensità, mentre la seconda si riferisce alla tendenza a sovrastimare le conseguenze negative delle manifestazioni del disgusto.
Domini del disgusto
Darwin correlava il disgusto prevalentemente al cibo, ma, successivamente, Rozin e altri colleghi hanno raggruppato i quattro differenti domini nei quali può manifestarsi disgusto:
- Core disgust: il disgusto di base, stimolato da alcuni alimenti, animali e prodotti corporei con lo scopo di proteggere il corpo dalla contaminazione.
- Animal reminder disgust: il disgusto che riporta alla nostra natura animale, il quale comporta ripugnanza verso oggetti e azioni che ci ricordano le nostre origini animali e la nostra mortalità.
- Interpersonal disgust: il disgusto interpersonale, che ha la funzione di proteggere l’anima e l’ordine sociale attivato dal contatto con altri indesiderabili.
- Moral disgust: il disgusto morale, attivato dalle infrazioni o reati morali a salvaguardia dell’ordine sociale.
Come si manifesta il disgusto
Per quanto riguarda le espressioni facciali, i segnali più significativi di disgusto si manifestano nella bocca e nel naso, mentre nelle palpebre inferiori e nelle sopracciglia il naso e ricciato, il labbro superiore è sollevato, mentre quello inferiore può essere sia sollevato che abbassato. In un’espressione di disgusto particolarmente intensa, le palpebre inferiori sono sollevate, mentre le sopracciglia abbassate.
Per quanto riguarda il comportamento nel complesso, la risposta al disgusto ha come obiettivo l’allontanamento dallo stimolo disgustoso. In base alla tipologia dello stimolo, quindi, cambierà anche la reazione: tapparsi il naso con le mani in caso di odori spiacevoli, chiudere rapidamente gli occhi se lo stimolo è visivo, allontanarsi fisicamente se lo stimolo è vicino a noi.
Grazie a tecniche di neuroimaging come l’fMRI (risonanza magnetica funzionale) si è visto che l’elaborazione del disgusto coinvolge specifiche aree cerebrali, tra cui l’amigdala, l’insula, i gangli della base e la corteccia parietale.
Per quanto riguarda l’aspetto fisiologico, la modificazione più comunemente associata alla reazione di disgusto riguarda il sistema digestivo e la regione della gola: nausea, vomito, oltre all’aumento della salivazione.
Quando il disgusto diviene un problema
È indiscutibile che il disgusto, storicamente molto meno indagato di altre emozioni nel campo della psicopatologia, giochi un ruolo fondamentale nell’eziopatogenesi e nel mantenimento di alcuni disturbi di natura psichica.
L’emozione di disgusto sembra giocare un ruolo fondamentale nella fenomenologia di molti disturbi psicopatologici riconosciuti, tra i quali alcune fobie specifiche (insetti, ragni, sangue ferite, iniezioni, etc.), ipocondria, disturbi alimentari, disturbi del desiderio sessuale, disturbo da stress post traumatico e la depressione.
L’emozione di disgusto è alla base del timore di contaminazione del disturbo ossessivo compulsivo (DOC) e spesso i sintomi di tale disturbo si strutturano attorno sull’idea di poter diventare sporchi e disgustosi. Ne derivano comportamenti di evitamento per prevenire la sensazione di disgusto oppure eventuali condotte compulsive volte ad alleviare il disagio esperito.

Photo 550433353 on Adobe Stock
C’è differenza tra disgusto e disprezzo?
Come altre emozioni, disgusto e disprezzo hanno un loro valore adattivo. Tali emozioni, essendo strettamente connesse al modo di percepire se stessi e il proprio modo di relazionarsi con l’ambiente esterno, consentono all’individuo di modulare al meglio le proprie relazioni sociali.
Nonostante nel linguaggio comune questi due termini vengano talvolta utilizzati come sinonimi, in ambito psicologico ci sono delle differenze.
Innanzitutto, il disgusto fa parte delle emozioni di base, mentre il disprezzo fa parte delle emozioni secondarie, come il senso di colpa, la gelosia e l’invidia.
Inoltre, se da un lato il disgusto è un’emozione innata, il disprezzo inizia a manifestarsi solo tra i 15 e i 18 mesi di vita e sembra che la sua manifestazione sia influenzata da regole sociali e culturali.
Il disprezzo non è indirizzato a sapori, odori e sensazioni, ma rivolto principalmente verso le persone e le loro azioni.
Il disprezzo è strettamente connesso a un senso di superiorità, soprattutto morale: disprezziamo le azioni delle altre persone quando non le riteniamo moralmente all’altezza rispetto a quelli che sono i nostri standard.
Mentre ci sono persone che non sono in grado di sopportare anche la minima sensazione di disgusto, ce ne sono altre appaiono orgogliose di mostrare disprezzo, come dimostrazione della loro “superiorità sociale”.
Le espressioni facciali di queste due emozioni si distinguono solo per l’intensità: quelle del disprezzo sono meno intense. Essendo però il disprezzo un’emozione strettamente connessa all’interazione sociale, può manifestarsi attraverso particolari reazioni verbali, quali ad esempio una battuta sarcastica, lo scherno, la derisione e persino l’insulto. Al contrario del disgusto, quindi, le reazioni più comuni del disprezzo non prevedono l’allontanarsi o lo sbarazzarsi dello stimolo, ma piuttosto hanno l’obietto di “demolirlo”, di renderlo inferiore.
Le emozioni del disgusto e del disprezzo appaiono essere estremamente funzionali al benessere dell’individuo e alla preservazione della specie. Infatti, da un lato tra le funzioni più antiche dell’emozione del disgusto c’è quella di impedire che l’organismo entri in contatto, ingerendoli, inalandoli o toccandoli, con alimenti o sostanze potenzialmente dannosi per l’organismo; dall’altro l’emozione più complessa e più evoluta del disprezzo consente alla Persona di modulare, rendendole più funzionali, le proprie relazioni sociali e di confrontarsi, anche nell’immediatezza del vissuto emotivo, con valori e norme di comportamento socialmente condivise.
Come gestire il disgusto
Non sempre è facile riuscire a gestire il disgusto. Se non ci piace un alimento possiamo non mangiarlo, ma se l’emozione del disgusto/disprezzo si esprime in ambito relazionale è diverso.
Se una Persona, con le sue azioni le sue idee, ci provoca disgusto o disprezzo possiamo evitarla o, se questo non è possibile, possiamo cercare di avere una comunicazione matura e costruttiva mettendoci in una posizione di ascolto e/o di spiegazione del nostro punto di vista, in modo da modulare la nostra risposta emotiva (regolazione emotiva).
E se abbiamo la sensazione di essere noi la causa del disgusto / disprezzo negli altri?
Può essere utile non mettersi sulla difensiva, accogliere il punto di vista dell’Altro e mediare i contenuti della comunicazione per evitare dinamiche conflittuali e/o disagi che si possono andare a strutturare creando uno stato di malessere personale e relazionale.
POSSO ESSERTI D’AIUTO?
Esplorare, riconoscere, accettare, risignificare, gestire, comprendere la funzionalità delle proprie emozioni, nonché acquisire consapevolezza circa le proprie capacità relazionali e comunicative, può essere utile per sperimentare una maggiore padronanza di se stessi e un maggiore senso di autoefficacia, ritornando a perseguire i propri obiettivi personali e professionali con determinazione, forza e libertà decisionale.
ACQUISIRE UNA MAGGIORE COMPETENZA EMOTIVA e individuare gli schemi mentali, emotivi e comportamentali, automatici e disfunzionali, appresi all’interno dei propri contesti significativi d’appartenenza e i circoli viziosi, che impediscono di vivere in uno stato di benessere psicologico e relazionale, può essere utile per prendere consapevolezza di Sé e della propria storia, pacificandosi con il passato, rivolgendo uno sguardo positivo al futuro, ma soprattutto vivere con intensità il presente.
Il percorso psicoterapeutico si avvale di tecniche e strumenti diversificati in base all’unicità della Persona e ai suoi bisogni (es. Terapia delle emozioni, terapia EMDR, Ipnosi ericksoniana, tecniche di psicoterapia cognitivo – comportamentale, tecniche di Mindfulness, tecniche immaginative, tecniche di rilassamento, l’apprendimento di tecniche di autoipnosi da utilizzare quotidianamente per gestire gli stati emotivi, strumenti grafici, la Fotovideo Terapia, home work, prescrizioni comportamentali, Carte Dixit, esercizi di role play, etc.) che consentono di rintracciare i costrutti o le credenze responsabili dell’attivazione disfunzionale di particolari emozioni e/o sentimenti, i quali vanno identificati, destrutturati e ristrutturati, facendo emergere modalità alternative e più adattive di costruzione della realtà.
Essere ascoltati e confrontarsi in uno spazio professionale, empatico e non giudicante è il primo passo per iniziare a prendersi cura di Sé.
Puoi contattarmi per chiedere informazioni o fissare un appuntamento, stabiliremo insieme come proseguire e, se Tu deciderai, inizieremo un percorso personalizzato, nel quale sarai parte attiva nel processo di ricerca del tuo benessere fisico, psicologico e relazionale.
Potrebbe interessarti
paura dei ragni
paura degli insetti