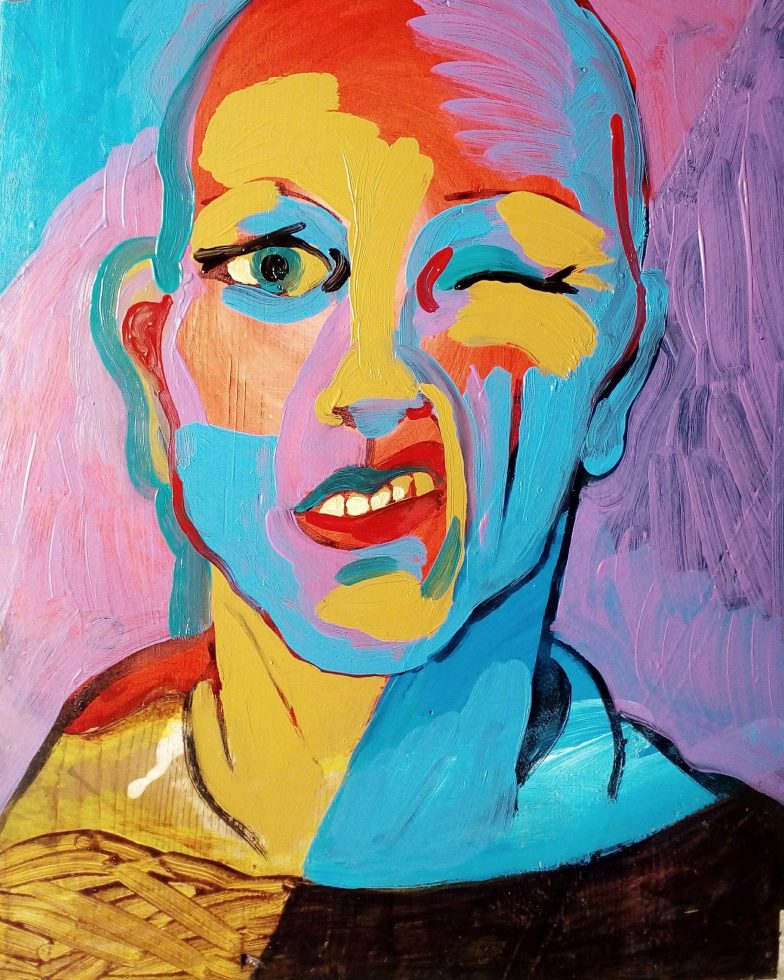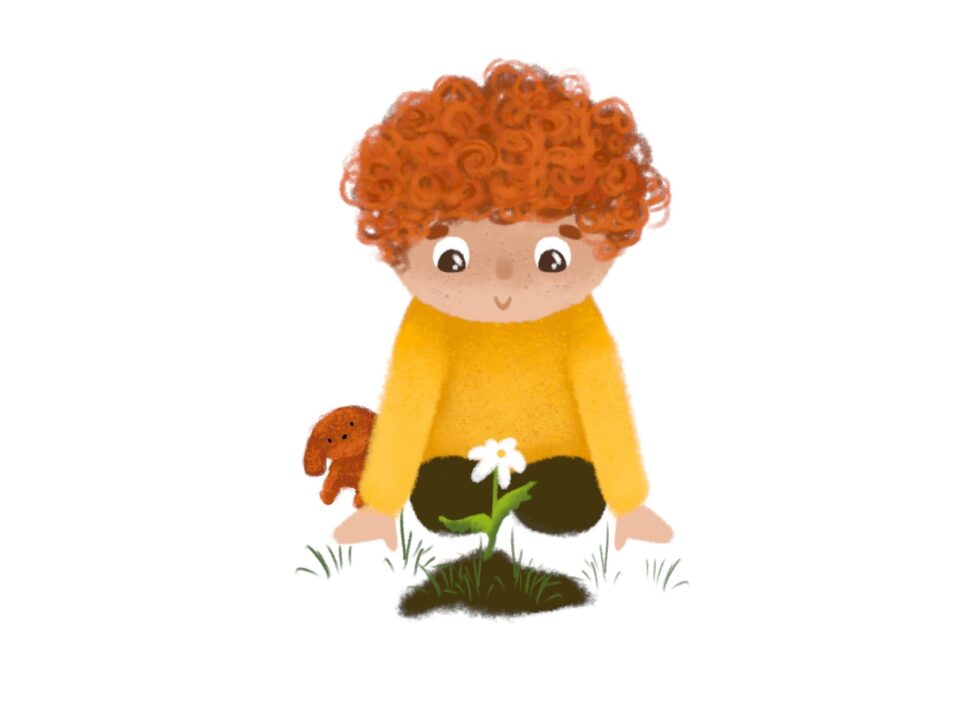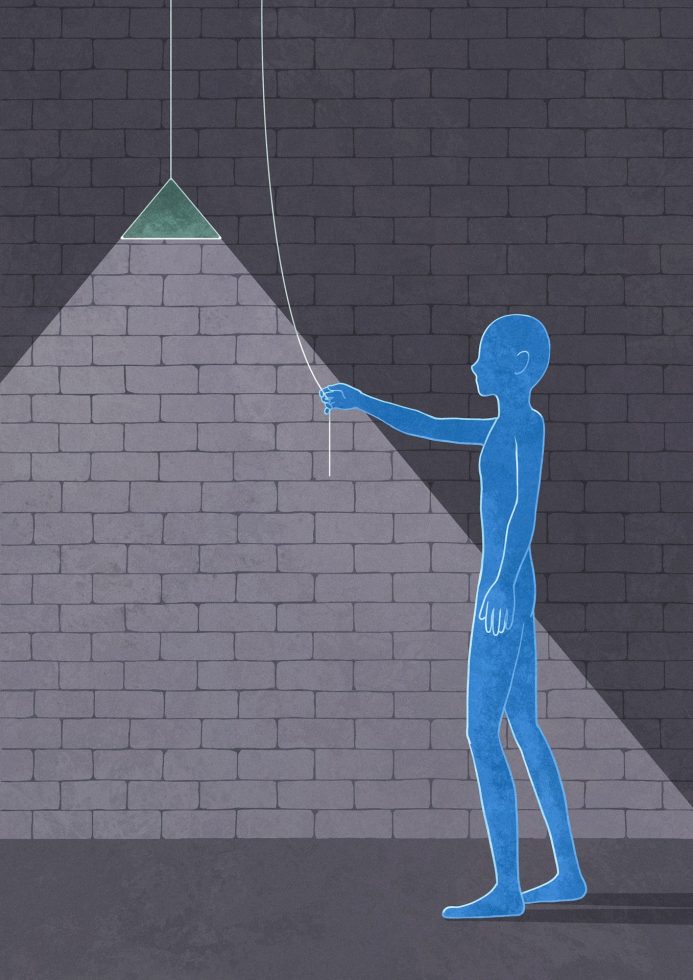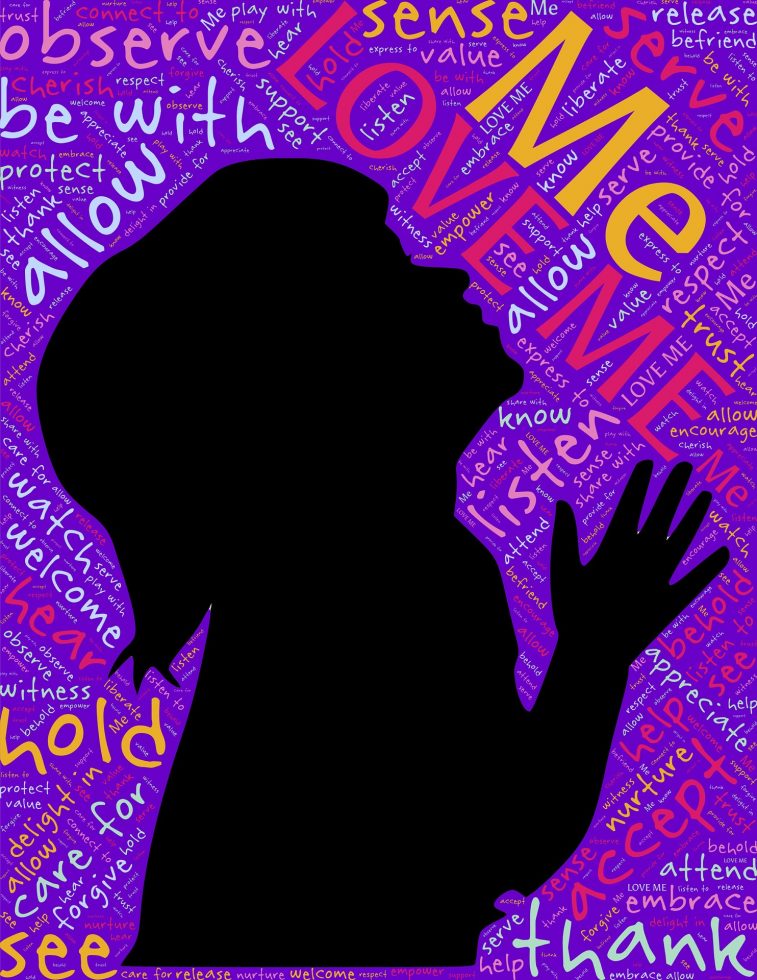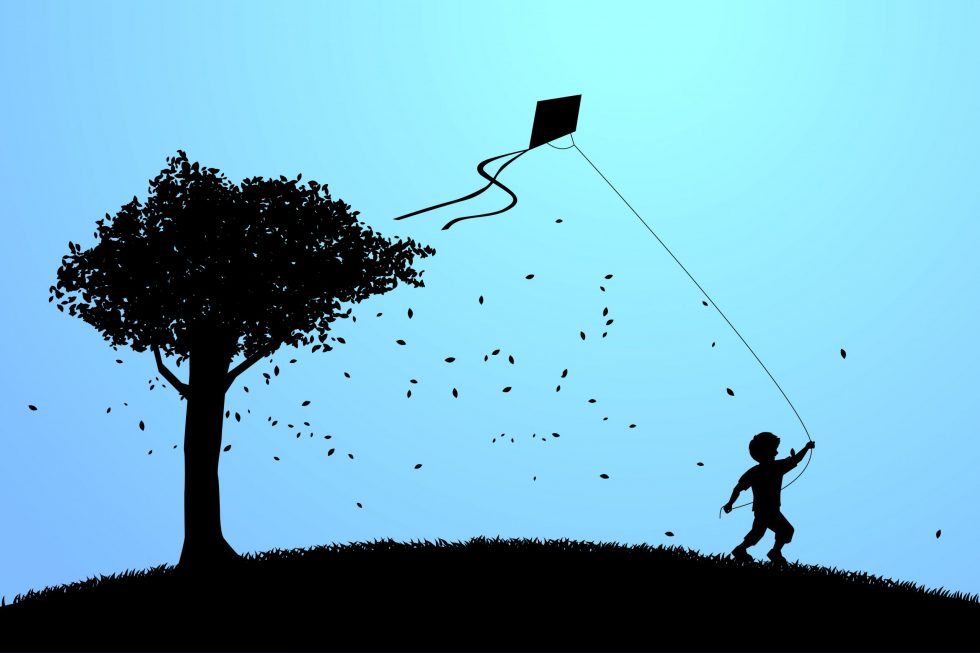Il disturbo d’ansia da separazione è il disturbo d’ansia più diffuso prima dei 12 anni e si caratterizza per la difficoltà del bambino di separarsi e/o allontanarsi dalla casa o da qualcuno della famiglia a cui è profondamente legato.
Questo disturbo si esprime nel momento del distacco, attraverso paure irrealistiche e persistenti circa il verificarsi di eventi catastrofici (es. gravi incidenti, rapimenti, uccisione o malattia) che li possano separare per sempre dai genitori e/o figure di riferimento.
L’ansia da separazione può comportare una forte riluttanza ad andare a scuola, in quanto ciò implica un allontanamento dai genitori o, più in generale, dalla figura primaria di riferimento. Spesso, questi bambini hanno difficoltà ad addormentarsi da soli e possono insistere affinché rimanga qualcuno con loro.
Quando si trovano ad essere separati dai genitori, i bambini tendono ad essere tristi, chiedono di telefonare ai genitori e di essere riportati a casa. Nei pazienti, si manifestano sintomi comportamentali, quali pianto e scatti di rabbia.
L’ansia di separazione può svilupparsi dopo qualche evento di vita particolarmente stressante, ad esempio, morte di un parente o di un animale domestico, episodio di ospedalizzazione del bambino o malattia di un familiare, separazione o divorzio dei genitori, cambiamento di scuola o trasloco etc.
Il disturbo può esprimersi per carenze affettive e/o di accudimento o, al contrario, da comportamenti iperprotettivi o intrusivi da parte dei genitori, che possono scoraggiare l’indipendenza del bambino.
La durata del disagio deve essere almeno di 4 settimane, iniziare prima dei 18 anni e causare disagio clinicamente significativo o compromissione dell’area sociale, scolastica o di altre aree importanti del funzionamento.
I bambini che esprimono ansia da separazione sono spesso descritti come richiedenti, intrusivi e bisognosi di attenzione costante. Le eccessive richieste del bambino spesso divengono una fonte di frustrazione per i genitori e talvolta portano a disagi e conflitti nel sistema familiare.
Spesso, se non trattati, questi bambini possono sviluppare in fase adolescenziale attacchi di panico, agorafobia o disturbi di personalità e forme di dipendenza affettiva nelle relazioni affettive nell’età adulta.
Sintomi dell’ansia da separazione
Tra i sintomi che possono esprimersi del Disturbo d’ansia da separazione, possono essere riportati:
- Difficoltà costante a lasciare il genitore e/o Persona di riferimento o la propria casa.
- Timore costante ed eccessivo che possa accadere qualcosa di tragico a un genitore e/o persona di riferimento.
- Timore costante ed eccessivo che si possa essere vittima di incidenti o rapimenti mentre si è soli.
- Rifiuto fermo e sistematico di allontanarsi da casa o di rimanere a casa da soli.
- Incubi ripetuti di separazione dai genitori e/o Persona di riferimento o di perdersi in un luogo ignoto.
- Comparsa di sintomi e malesseri fisici, veri o presunti, come mal di testa, dolori addominali ecc. ogni volta che ci si deve allontanare da casa o dai genitori e/o Persona di riferimento.
- Tendenza a essere molto “appiccicosi”, invadenti, a richiedere attenzione e presenza costanti.
- Umore ansioso e depresso, apatia e disinteresse, irrequietezza e forte malinconia se costretti a restare soli lontano da casa.
Cosa possono fare i genitori?
- Evitare di anticipare o rendere particolarmente evidenti i momenti di separazione.
- Quando si deve uscire di casa o lasciare solo il bambino, per esempio a scuola, salutarlo con affetto, ma senza eccessivo coinvolgimento emotivo.
- Allontanarsi da casa quando il bambino è in uno stato di benessere, ad esempio riposato e non affamato.
- Trovare un diversivo allegro che possa distrarre il bambino durante la vostra assenza, ad esempio un gioco preferito.
- Abituare gradualmente il bambino a restare solo con persone diverse dai genitori, per esempio, nonni, zii, educatori, etc.
- Regalare al bambino un oggetto che possa in qualche modo ricordare la presenza del genitore, quando assente.
- Compatibilmente con l’età, insegnare al bambino a prendersi personalmente cura di un piccolo animale o di una pianta.
Il Disturbo d’ansia da separazione a SCUOLA: come si manifesta?
Le difficoltà del bambino a separarsi dalla mamma o dal papà hanno un forte impatto sulla frequenza scolastica e sulla socializzazione del bambino e si può manifestare con:
- Frequenti ritardi.
- Pianto.
- Rifiuto di recarsi a scuola.
- Evitare di svolgere attività con i coetanei oltre l’orario scolastico.
- Bassa autostima in situazioni sociali e in ambito educativo/scolastico.
- Difficoltà di concentrazione.
- Basso rendimento scolastico.
- Lentezza nell’esecuzione dei compiti.
- Frequenti domande e richieste di rassicurazione.
Cosa possono fare gli insegnanti?
- Instaurare una buona collaborazione e comunicazione con la famiglia. Condividere gli obiettivi e le strategie utilizzate nella gestione del bambino può consentire di lavorare in un’unica direzione.
- Rispettare le emozioni del bambino. Paura e ansia per la separazione da mamma o papà sono reali. Non risulta efficace criticate il bambino utilizzando frasi del tipo “Solo i bambini piccoli si comportano così”.
- Concordare con i genitori un piano per il rientro graduale a scuola. Nel caso in cui il bambino manifesti il rifiuto di andare a scuola, può essere utile stabilire degli orari e dei giorni in cui il bambino può farvi ritorno, anche se per poco tempo.
- Accogliere con pazienza eventuali ritardi. Può essere utile consentire ai genitori e al bambino di parlare con calma e svolgere i loro rituali prima di separarsi. Il miglior consiglio da dare ai genitori è quello di creare una routine per salutare il bambino. Gli insegnanti dovrebbero aiutare la mamma e il papà a determinare il luogo e il tempo necessario per lo svolgimento di questa routine.
- Sostenere il bambino nelle relazioni con i compagni. Il disturbo potrebbe farlo allontanare progressivamente dagli amici fino a spingerlo all’isolamento.
- Consentire al bambino di mantenersi in contatto con i genitori. Stabilite uno o due momenti durante la mattinata in cui l’alunno può parlare, per un breve periodo, con la mamma o con il papà.
- Fornire una cornice. A inizio giornata può essere utile condividere con il bambino le attività che verranno svolte durante la giornata di scuola.
- Rinforzare gli sforzi del bambino. Premiate ogni sforzo messo in atto dal bambino che si avvicina agli obiettivi concordati in precedenza.
- Evitare di punire il bambino per la sua difficoltà, non squalificarlo e non farlo sentire diverso dagli altri.
Che significato ha il sintomo?
La Persona che porta il carico del problema è definita dalla modello psicoterapeutico sistemico relazionale con il termine “paziente designato”, ovvero colui/colei che esprime il sintomo, facendosi portavoce del disagio di tutti.
Il sintomo può acquisire un doppio significato: da un lato segnala il disagio di tutto il sistema familiare, poiché la sofferenza di un componente della famiglia appartiene implicitamente a tutti, dall’altro segnala la necessità di cambiamento di quel sistema in quanto l’espressione di un sintomo implica una non funzionalità e/o un blocco dell’evolutività del singolo e del sistema famiglia.
Il disagio può risalire a ridondanti e stereotipati modelli relazionali disfunzionali che spesso si ripetono nelle famiglie da varie generazioni, regole, schemi antichi, difficoltà nel processo di differenziazione del singolo, triangolazioni familiari, miti lontani, mandati familiari da accogliere e modificare in un contesto terapeutico strutturato.
Il terapeuta sistemico relazionale riconosce nel sintomo un’opportunità per la Persona che lo esprime, di far emergere la sua individuale sofferenza, nonché la possibilità per il sistema famiglia o il sistema coppia di spezzare schemi relazionali che invalidano l’evoluzione del singolo e del sistema stesso.
Divenire consapevoli del significato dei sintomi significa attribuirgli un nuovo senso, aprendosi a possibilità di pensiero e di comportamento nuove e più consapevoli rafforzando il proprio senso di Sé, ma anche i rapporti familiari e/o di coppia attraverso la rivalutazione positiva del proprio ruolo all’interno dei propri contesti relazionali.
Intervento terapeutico
Nei bambini, il pianto, gli scoppi di rabbia e la difficoltà a lasciare il genitore sono reazioni normali alla separazione. Alcuni bambini, tuttavia, sperimentano uno stato d’ansia all’atto della separazione che tende a non decrescere nel tempo, nonostante gli sforzi dei genitori. Se il bambino sperimenta per mesi un livello d’ansia tale da interferire con lo svolgimento delle normali attività scolastiche e sociali, può essere un segno di una complessità maggiore.
L’intervento psicologico si struttura analizzando la complessità del quadro sintomatologico, comprendente la dimensione cognitiva, fisiologica, comportamentale, psicologica, emotiva e socio relazionale della Persona.
Il percorso si avvale di tecniche e strumenti diversificati in base all’unicità della Persona e ai suoi bisogni con lo scopo di rintracciare i costrutti o le credenze responsabili dell’attivazione disfunzionale dell’ansia da separazione, i quali vanno identificati, destrutturati e ristrutturati, facendo emergere modalità alternative e più adattive di costruzione della realtà.
L’intervento terapeutico consente di approfondire la storia di vita della Persona, la storia del sintomo e il significato dello stesso all’interno dei mondi relazionali di appartenenza (famiglia, scuola, attività extrascolastiche, etc.), destrutturando ed elaborando gli schemi che attivano e mantengono il disturbo di ansia da separazione e le emozioni connesse ad esso. Si procederà attraverso:
- L’educazione all’ansia. Il terapeuta spiega al bambino o all’adolescente cos’è il disturbo d’ansia da separazione, la sintomatologia con cui si manifesta e i comportamenti che lo mantengono nel tempo.
- L’individuazione e la modificazione dei pensieri disfunzionali. Ai bambini o ai ragazzi viene insegnato ad individuare le “cognizioni errate” legate alle situazioni di separazione. Successivamente si condividerà con lui la possibilità di valutare le situazioni in modo diverso, in modo da poterle affrontare con pensieri più funzionali e realistici.
- L’esposizione. Questa tecnica consiste nel provare gradualmente ad affrontare le situazioni temute. L’esposizione alle situazioni di separazione permetterà al bambino o all’adolescente di verificare che queste non comportano un reale pericolo, imparando, inoltre, che affrontare e gestire l’ansia è possibile.
- Il rinforzo. Ogni comportamento tenuto dal bambino o adolescente, a casa, a scuola, a lavoro o in terapia che si avvicina all’obiettivo prefissato, verrà rinforzato, connotandolo positivamente verbalmente e/o attraverso premi (in base all’età).
- Il modellamento. Si basa sull’utilizzo dell’esempio dell’adulto come modello funzionale di comportamento nell’affrontare le situazioni di separazione dai genitori o da altri adulti.
- La costruzione della resilienza. Viene condiviso con i bambini o ragazzi che pur non potendo controllare gli eventi, è possibile modificare l’impatto che essi hanno su di loro.
Nel caso di bambini e adolescenti, il coinvolgimento dei genitori è di fondamentale importanza. Un percorso di accompagnamento alla genitorialità e/o di terapia familiare può consentire ai genitori di imparare a rispondere alle richieste dei figli, in modo da non rinforzare le loro paure e di conseguenza mantenere il sintomo, nonché a riscoprire o acquisire nuove competenze genitoriali utili ad un cambiamento evolutivo per il singolo e l’intero sistema famiglia.
POSSO ESSERTI D’AIUTO?
Essere ascoltati e confrontarsi in uno spazio professionale, empatico e non giudicante è il primo passo per iniziare a prendersi cura di Sé o di qualcuno importante per Te.
Puoi contattarmi per chiedere informazioni o fissare un appuntamento.