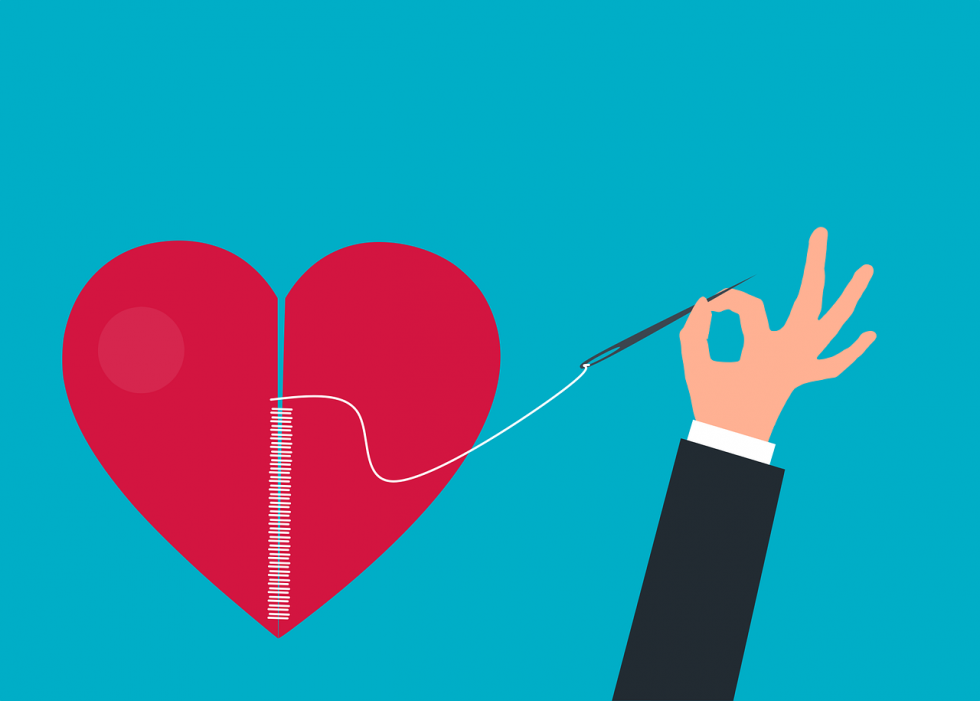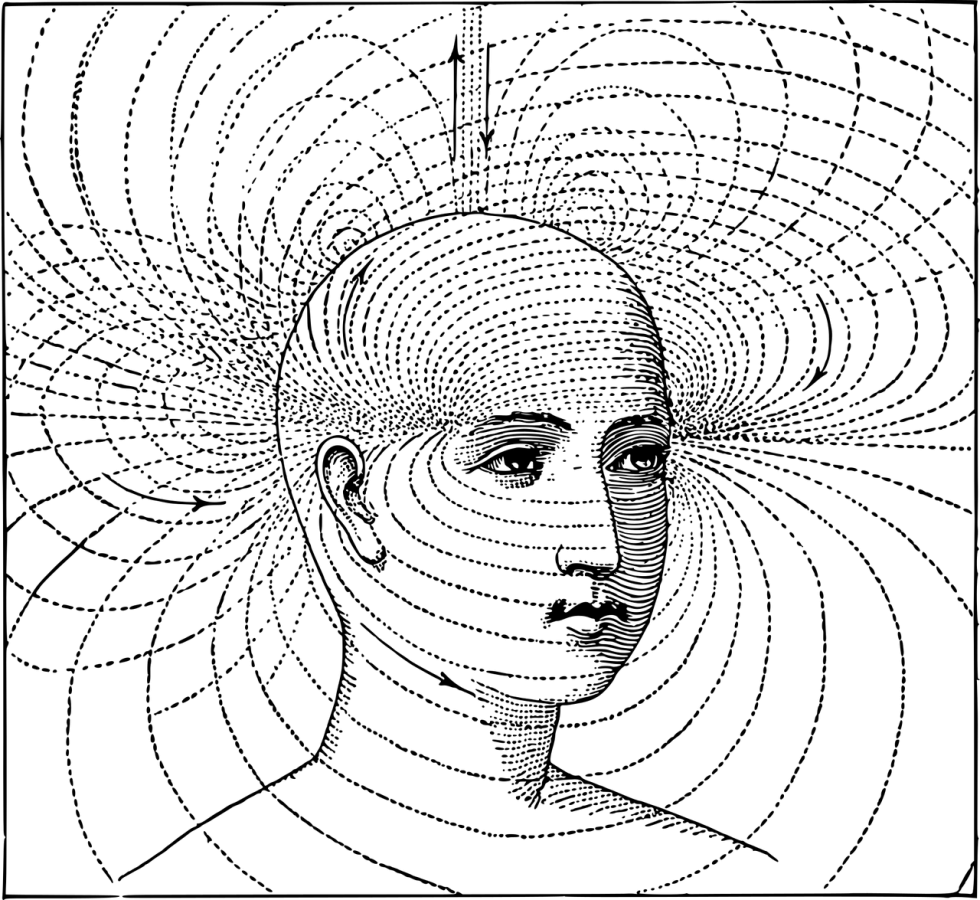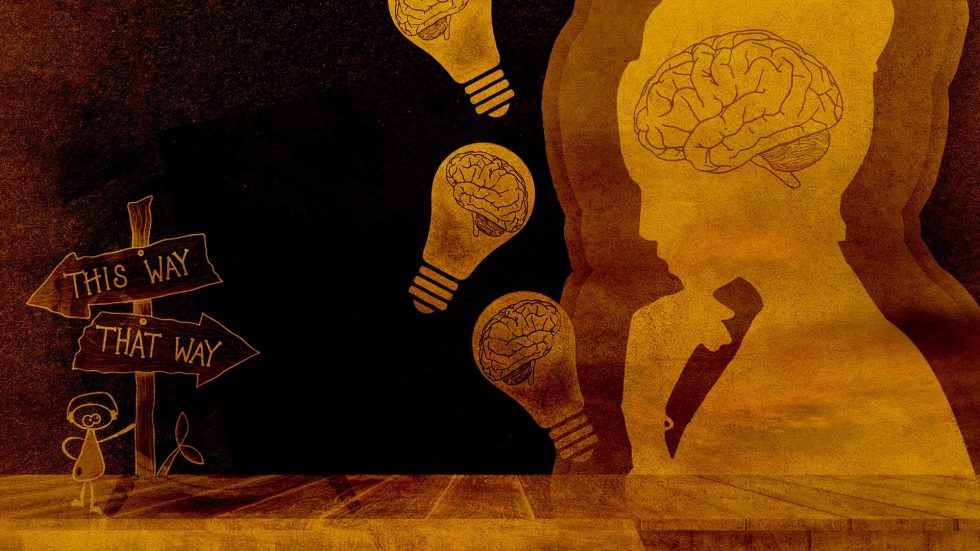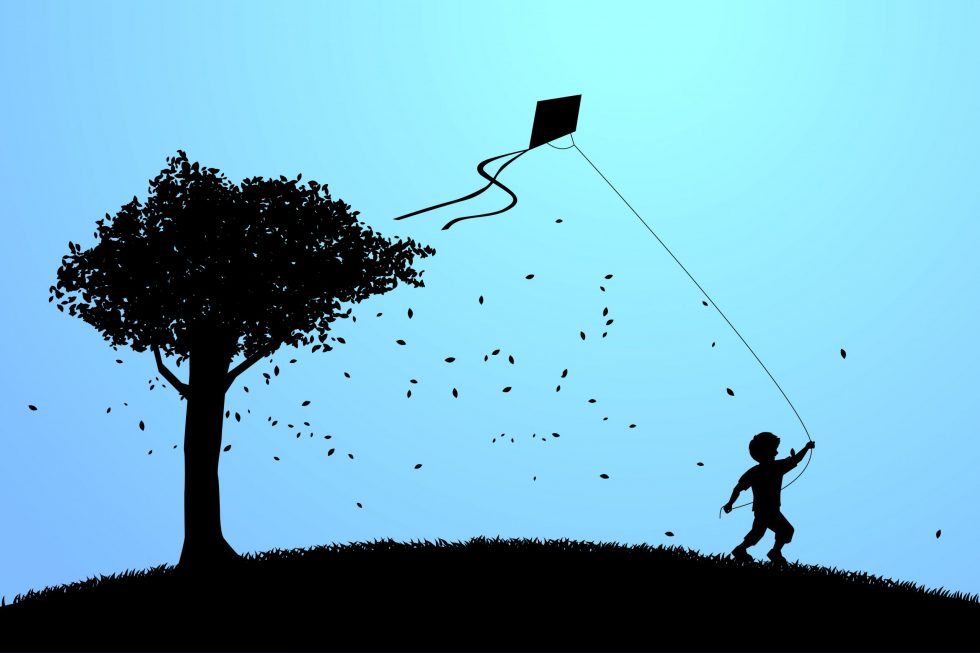Da più di un decennio sono ormai comparsi in letteratura numerosi studi che analizzano la depressione post partum paterna. Sebbene questo fenomeno, prima trascurato, sia oggetto di studi sperimentali nonché di interesse clinico, non esiste ancora un quadro diagnostico definito.
La nascita di un bambino è senza dubbio un evento stressante. Diventare genitori significa doversi adattare a molti cambiamenti di natura organizzativa, emotiva e sociale.
Molte madri e padri possono avere una difficoltà iniziale nell’accogliere e nello sperimentarsi in un nuovo ruolo di genitore e di compagno o marito e di lavoratore.
L’idealizzazione culturale di una genitorialità positiva ed entusiasmante può creare aspettative irrealistiche, conducendo i genitori a vivere un senso di inefficacia e sentimenti di fallimento per non riuscire a provare o ad agire come ci si aspetta socialmente.
In tal senso, responsabilità e aspettative possono far provare un senso di sopraffazione ai genitori, soprattutto alla prima esperienza, andando incontro, talvolta, a stati ansiosi o depressivi.
Se le condizioni di disagio della neomamma, attraver
so un’assistenza specialistica, possono essere riconosciute, distinte e fronteggiate attraverso un efficace intervento terapeutico, quelle dei neopapà possono apparire sottovalutate, nonostante sia sottolineata la significatività della loro figura nel superamento della condizione di sofferenza della neomamma.
L’idea primitiva che tutt’oggi permane, ovvero che la figura che si occupa del neonato deve essere prevalentemente la mamma, non consente ai neopapà di poter esprimere eventuali segni di sofferenza psicologica, derivanti dai significativi cambiamenti mentali ed emotivi sollecitati dall’arrivo di un bambino e, conseguentemente, chiedere aiuto.
Come insorge la depressione post partum paterna
Le nuove esigenze e responsabilità sono il punto di inizio dei grandi cambiamenti di vita per la neomamma e il neopapà.
In questo processo fattori psicologici, sociali e biologici possono determinare l’insorgere della depressione post partum paterna.
Rispetto alle madri, le quali dovrebbero, istintivamente, al momento della nascita del figlio, sviluppare un legame emotivo con lo stesso, nei papà lo sviluppo del legame emotivo con il proprio bambino può avvenire anche gradualmente nei primi due mesi di vita.
Un fattore di rischio può essere la mancanza di ricompense e gratificazioni, come ad esempio, il sorriso del proprio bambino che funge da rinforzo degli atteggiamenti paterni. Soprattutto nei primi mesi di vita, il neopapà può sentirsi isolato e percepire un sentimento di gelosia del legame madre – figlio.
Sintomi della depressione post partum paterna
Per ciò che concerne la sintomatologia psicologica, uno degli stress più significativi sembra essere quello legato alla difficoltà di accettare la nuova struttura familiare e le responsabilità che ne conseguono. Questo renderebbe complesso per il neopapà prendersi cura in modo adeguato della partner e del figlio sia da un punto di vista pragmatico che emotivo, andando incontro a un abbassamento del tono dell’umore per il senso di inefficacia sperimentato.
Sintomi quali irritabilità, indecisione, spegnimento emotivo, nonché sensazione di fallimento e ansia, possono condurre anche ad esprimere momenti di conflittualità con la partner.
Le sensazioni di soffocamento e sovraccarico, spesso dovute alla frenetica organizzazione quotidiana, possono indurre cambiamento nei ritmi fisiologici e frequente insonnia.
Un altro fattore di rischio può essere l’assenza di un buon modello genitoriale. Spesso, i papà non hanno acquistato le competenze genitoriali dai propri genitori o familiari significativi, conducendo ad un possibile stato di ansia per non sentirsi in grado di affrontare la responsabilità sia da un punto di vista pragmatico che emotivo legate alla nascita del figlio.
Gli improvvisi cambiamenti di vita incidono sulla relazione di coppia e connessa ad essa, tra i fattori di rischio possono emergere la mancanza di intimità e la perdita dell’interesse sessuale verso il partner, la trasformazione della coppia da 1+1 =2 a 1+1 = 3, il cambiamento nella qualità e quantità dei “tempo della coppia”, sperimentando, talvolta, un senso di abbandono da parte della partner che rivolge tutte le sue attenzioni al bambino, oppure alla crescita della famiglia dove sono già presenti altri figli e tutte le responsabilità che ne conseguono.
Lo stress di diventare papà include anche la pressione sull’uomo, idea ancora molto diffusa nella società attuale, di dover aumentare il proprio sostegno finanziario dopo la nascita del bambino, impedendo, talvolta, al padre di essere fortemente coinvolto nella genitorialità.
Anche la sensazione da parte del neopapà di limitazione di libertà e di possibilità progettuale sia di coppia che individuale connessa alla nascita di un figlio è un fattore di rischio. Possono emergere stati ansiosi che possono far sperimentare senso di oppressione e pensieri negativi, cristallizzando l’idea che “non sarò mai più libero!”, facendo fatica a adattarsi alla genitorialità.
Anche la mancanza di sonno e le alterazioni dei ritmi organizzativi della vita quotidiana possono essere associati all’insorgere della depressione post partum paterna, come anche aver sperimentato una pregressa storia di depressione personale o familiare.
Da un punto di vista biologico, recenti studi presso l’Università della California hanno messo in luce un’alterazione ormonale piuttosto peculiare nei neopapà, ovvero, accade spesso che, dopo la nascita dei figli, si abbassano i livelli di testosterone. Questo fenomeno è stato a lungo interpretato come un’alterazione fisiologica adattiva che favorisce un “allineamento” con il mood della madre, nonché alla sintonizzazione della coppia genitoriale ad essere più sintonizzata circa le richieste di accudimento del bambino. Se da un lato questo fenomeno può predisporre ad un abbassamento del tono dell’umore (e quindi ad un esordio depressivo) è stato altresì osservato che i padri che mantengono un alto livello di testosterone riportano maggiore stress genitoriale e una maggiore predisposizione a modalità aggressive nella famiglia e in coppia.
Per ciò che concerne le motivazioni dell’insorgere della depressione post partum, gli studi evidenziano una differenza tra Depressione post partum e depressione paterna. Se la depressione post partum nelle donne è più frequentemente associata a fattori cronici ed intrapsichici, è possibile che quella paterna sia più legata a variabili sociali e relazionali e, per questo, più esposta a fluttuazioni nel tempo.
Intervento terapeutico
Si condivide che agire sulla depressione post partum paterna in ottica preventiva è la via preferenziale.
Far partecipare i neopapà soli o insieme alla neomamma a un percorso di accompagnamento alla nascita e/o al protocollo Mindfulness Based Childbirth and Parenting (per genitori in attesa e per la neogenitorialità) ha lo scopo di migliorare l’impatto dello stress legato ai cambiamenti indotti dalla gravidanza, dal parto e dalla genitorialità, limitare l’idealizzazione di una genitorialità esclusivamente positiva, dando un’idea pragmatica di quello che può accadere.
A livello psicologico può essere utile lavorare sulla relazione di coppia e sugli stati emotivi d’impotenza, di frustrazione, nonché sulle aspettative che erano presenti prima della nascita del figlio del neopapà, sull’eventuale senso di colpa per non provare ciò che socialmente si ritiene corretto e giusto e sui modelli familiari introiettati dalla propria storia personale.
Affinché l’intervento possa essere efficace a lungo termine, può essere utile un percorso di psicoterapia individuale e/o di coppia, attraverso il quale il neopapà può ricevere il sostegno psicologico necessario per superare il difficile momento, mentre la coppia può trovare uno spazio di riflessione adeguato ad affrontare in senso adattivo tutti i cambiamenti che la nascita di un figlio comporta.
L’intervento psicologico è sostenuto da un ascolto attivo e una comunicazione empatica che può consentire al neopapà di sentirsi non giudicato nell’esprimere i propri stati emotivi inerenti al suo nuovo ruolo di uomo, di papà, di compagno, di figlio e alla propria progettualità personale e professionale.
Durante l’intervento terapeutico, l’analisi delle tentate soluzioni utilizzate per gestire la situazione può essere uno spunto per introdurne di più efficaci, modificando degli schemi cognitivi, emotivi e comportamentali disturbanti e disfunzionali che sostengono la sintomatologia ed introdurne di più adattivi.
POSSO ESSERTI D’AIUTO?
Essere ascoltati e confrontarsi in uno spazio professionale, empatico e non giudicante è il primo passo per iniziare a prendersi cura di Sé.
Puoi contattarmi per chiedere informazioni o fissare un appuntamento.
Potrebbe interessarti