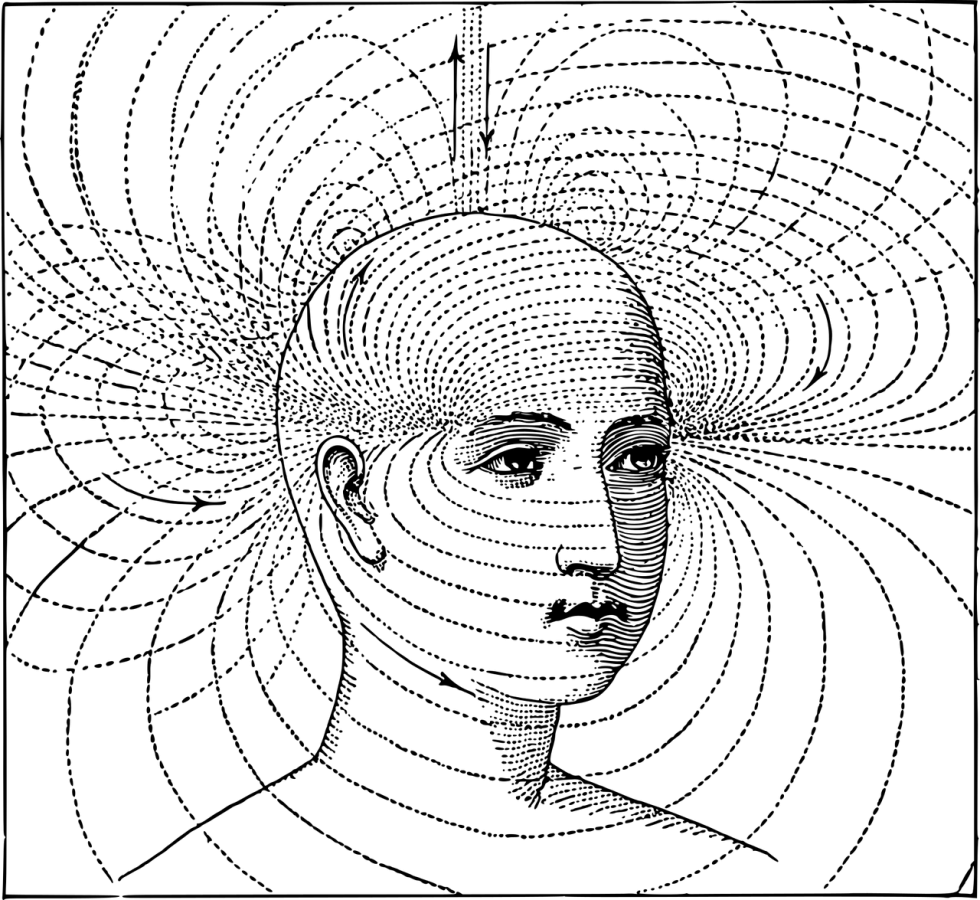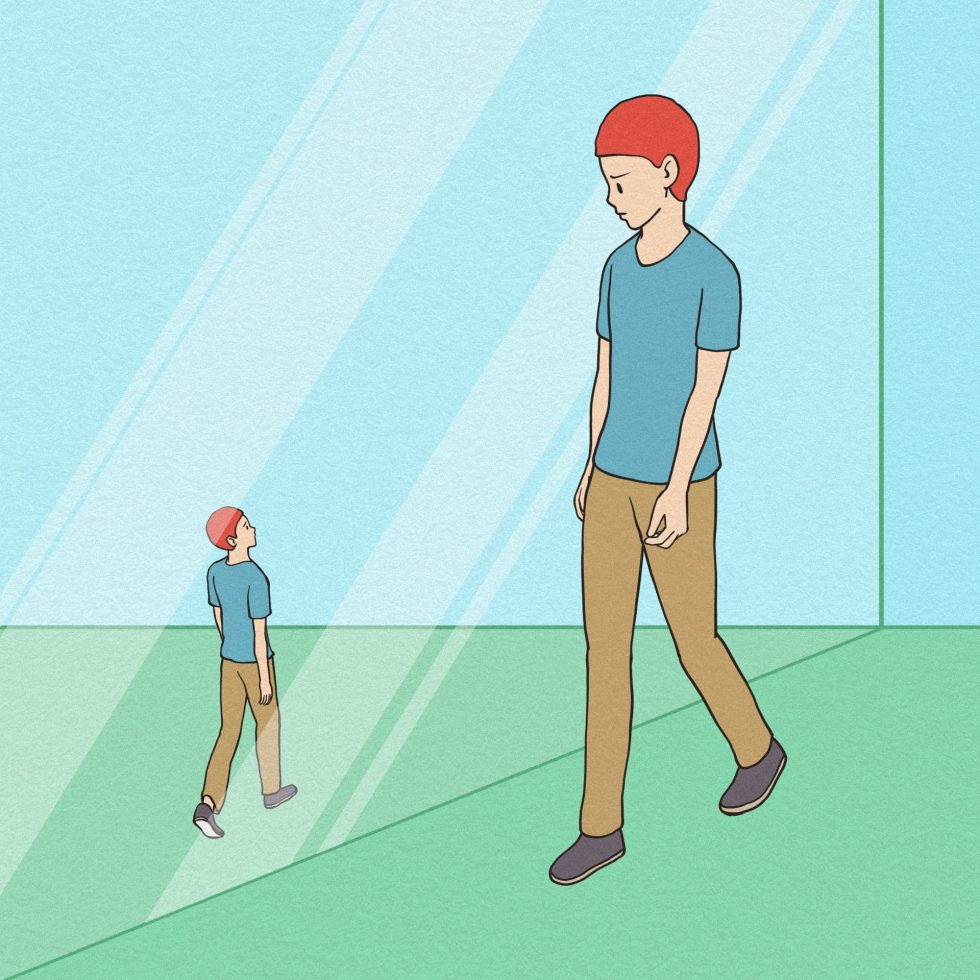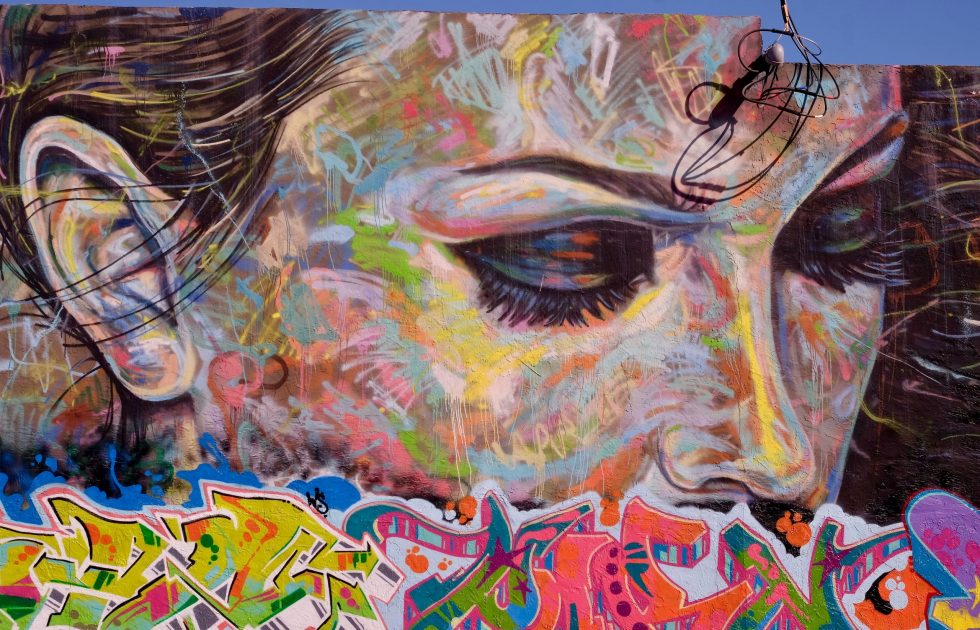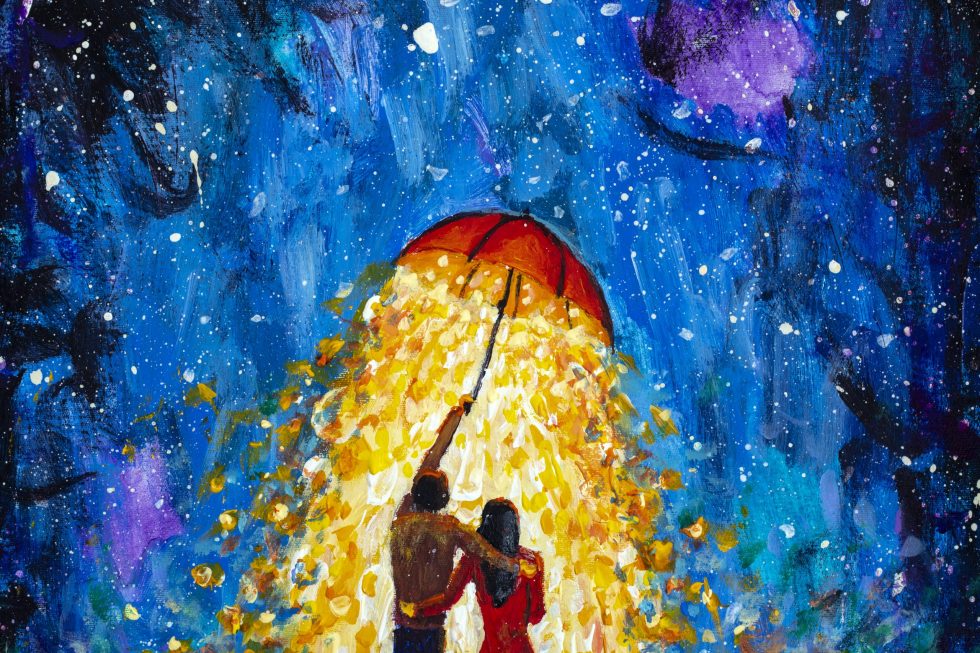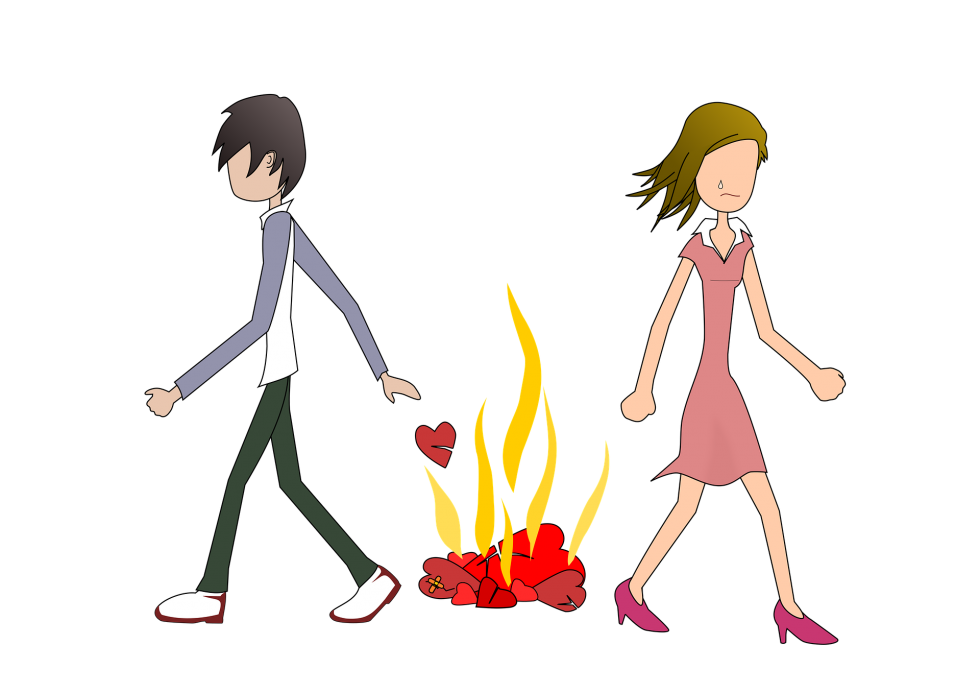Tutte le teorie psicologiche delle emozioni condividono che le reazioni emotive hanno una funzione adattativa per la Persona e per la specie. In questo senso, se alle emozioni primarie, quali felicità, tristezza, paura, rabbia, disgusto, si attribuiscono funzioni e scopi evolutivi semplici, ovvero mantenere i legami affettivi con le figure di attaccamento, segnalare l’esistenza di pericoli, difendersi dagli attacchi e dalle circostanze pericolose, alle emozioni secondarie si attribuiscono funzioni maggiormente evolute e connesse alla formazione della consapevolezza di se stessi e alla regolazione delle proprie relazioni con gli altri.
In quest’ottica, l’imbarazzo è un’emozione sociale connessa alla percezione che ciascuno di noi ha di se stesso e delle proprie caratteristiche in relazione agli altri.
In termini di vissuti emotivi, per imbarazzo si intende uno stato più o meno intenso e di durata variabile che si manifesta esclusivamente in una situazione sociale, caratterizzato da modificazioni psicofisiologiche e manifestazioni comportamentali esprimenti disagio.
Perché ci si imbarazza?
Tutti gli studiosi, siano essi sociologi, antropologi o psicologi, concordano nel legare il vissuto dell’imbarazzo ad eventi che mettono in crisi l’immagine pubblica della Persona e nel connettere tale vissuto emotivo al presente, al luogo dell’azione, nonché ad altre possibili persone presenti in quel momento.
Un altro punto d’accordo tra gli studiosi è l’aver rilevato come spesso le situazioni che generano imbarazzo sono quelle in cui mancano norme esplicite di comportamento, quelle dove non è ben chiaro quali siano le norme comportamentali più adeguate o socialmente accettate. Un esempio tipico è quello in cui ci si trova in due in un ascensore, non si sa mai quali atteggiamenti o comportamenti tenere e questo genera imbarazzo.
Secondo il Prof. Cristiano Castelfranchi, ricercatore presso l’Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche e docente di Psicologia cognitiva e intelligenza artificiale, invece, il nucleo dell’imbarazzo consisterebbe in una perdita, avvenuta o temuta e comunque momentanea, della propria autostima situazionale: è il caso, ad esempio di una persona in genere agile, che in una particolare circostanza e di fronte ad altri si è mostrata goffa e impacciata.
Dalle ricerche delle psicologhe Valentina D’Urso e Rosanna Trentin, le condizioni che normalmente devono essere presenti perché insorga l’imbarazzo sono:
- la consapevolezza che un proprio comportamento è regolato da norme sociali;
- la presenza di un pubblico e in particolare il sentire su di sé l’attenzione degli altri;
- desiderio di conformarsi alle norme e il timore di infrangerle;
- l’insicurezza sulle proprie capacità e quindi la paura di perdere la faccia davanti agli altri.
Quando ci si imbarazza?
Non esiste una risposta univoca a questa domanda perché molto dipende da quali sono i valori, le regole che ciascuna Persona ha introiettato durante la sua vita e soprattutto quale percezione ha della propria immagine e del proprio Sé e quale desidera preservare davanti agli altri.
È possibile individuare alcune situazioni nelle quali più che in altre è possibile provare imbarazzo.
- In genere queste situazioni sono connesse ad un fallimento in pubblico, alla perdita del contegno o del controllo del proprio corpo, all’intimità emotiva e fisica.
- Esistono situazioni nelle quali siamo imbarazzati per l’imbarazzo di qualcuno che ci è vicino, oppure circostanze nelle quali noi lo sperimentiamo al posto di qualcun altro.
- Altra situazione, che spesso genera imbarazzo, è l’essere oggetto di lodi o di attenzione. In questo caso l’imbarazzo si genera non tanto per la situazione di per sé positiva quanto per il timore o la sensazione di dover subire ulteriori valutazioni e quindi di non dimostrarsi all’altezza della situazione.
Cosa ci succede quando siamo imbarazzati?
Le manifestazioni comportamentali tipiche dell’imbarazzo, quali il rossore, l’irrequietezza motoria, le alterazioni della voce, oltre a segnalare agli altri lo stato emotivo in cui ci si trova, agiscono come causa di ulteriore imbarazzo. Si tratta di un rinforzo circolare che opera per l’imbarazzo più che per ogni altra emozione.
Come riportato nel testo “Sillabario delle emozioni” (1992), D’Urso e Trentin descrivono che:
- A LIVELLO COMPORTAMENTALE, l’imbarazzo si esprime soprattutto con il distogliere lo sguardo dall’interlocutore, abbassandolo o deviandolo su punti dello spazio per nulla interessanti; la postura può essere o estremamente rigida con pochissimi movimenti o al contrario presentare movimenti irrequieti di braccia, gambe, mani e continui cambi di posizione. Inoltre, quando ci si sente imbarazzati si mettono in atto dei comportamenti tesi ad allentare la tensione emotiva, quali toccarsi ripetutamente i capelli o giocherellare con piccoli oggetti.
- A LIVELLO LINGUISTICO, la voce diventa stridula, con tonalità irregolari, spesso si balbetta o si incespica, il volume della voce si alza e/o si abbassa rispetto alla propria norma, si fanno insoliti errori di grammatica, vi sono esitazioni, false partenze, lunghe pause tra una parola e l’altra.
- A LIVELLO LINGUISTICO, il segnale caratteristico dell’imbarazzo è l’arrossarsi in modo repentino del viso e del collo, fattore dovuto ad una vasodilatazione periferica; il battito del cuore rallenta (anche se spesso si pensa che aumenti), la temperatura corporea si innalza o ha degli sbalzi, i vasi sanguigni si dilatano, aumenta la tensione muscolare, la respirazione si fa irregolare, si suda di più e la motilità gastrica così come la secchezza delle fauci aumentano.
Che fare quando si è in imbarazzo?
D’Urso e Trentin (1992) nel loro libro “Sillabario delle emozioni” riportano alcuni accorgimenti da adottare in situazioni imbarazzanti:
POSSO ESSERTI D’AIUTO?
Sentirsi in imbarazzo non è piacevole e per quanto possibile si cerca di evitare occasioni che possano alimentare questo stato emotivo. Tuttavia, l’imbarazzo rivela ciò che per noi conta, il valore che attribuiamo a noi stessi, agli altri e agli eventi. Provare imbarazzo significa aver investito sull’Altro o sulla situazione che scaturisce questo stato emotivo.
Esplorare, riconoscere, accettare, risignificare, gestire, comprendere la funzionalità delle proprie emozioni, nonché acquisire consapevolezza circa le proprie capacità relazionali e comunicative, può essere utile per sperimentare una maggiore padronanza di se stessi e un maggiore senso di autoefficacia, ritornando a perseguire i propri obiettivi personali e professionali con determinazione, forza e libertà decisionale.
Nel caso dello stato emotivo dell’imbarazzo il processo terapeutico può essere utile per accettare la possibilità di commettere azioni o di trovarsi in situazioni imbarazzanti, ridimensionare il valore e/o giudizio che gli altri possono dare ai nostri comportamenti, potenziare il proprio senso di autostima rivalutando il Sé e la propria immagine.
ACQUISIRE UNA MAGGIORE COMPETENZA EMOTIVA e individuare gli schemi mentali, emotivi e comportamentali, automatici e disfunzionali, appresi all’interno dei propri contesti significativi d’appartenenza e i circoli viziosi, che impediscono di vivere in uno stato di benessere psicologico e relazionale, può essere utile per prendere consapevolezza di Sé e della propria storia, pacificandosi con il passato, rivolgendo uno sguardo positivo al futuro, ma soprattutto vivere con intensità il presente.
Il percorso psicoterapeutico si avvale di tecniche e strumenti diversificati in base all’unicità della Persona e ai suoi bisogni (es. Terapia delle emozioni, terapia EMDR, Ipnosi ericksoniana, tecniche di Mindfulness, tecniche immaginative, tecniche di rilassamento, l’apprendimento di tecniche di autoipnosi da utilizzare quotidianamente per gestire gli stati emotivi, strumenti grafici, la Fotovideo Terapia, home work, prescrizioni comportamentali, Carte Dixit, esercizi di role play, etc.) che consentono di rintracciare i costrutti o le credenze responsabili dell’attivazione disfunzionale di particolari emozioni e/o sentimenti, i quali vanno identificati, destrutturati e ristrutturati, facendo emergere modalità alternative e più adattive di costruzione della realtà.
Essere ascoltati e confrontarsi in uno spazio professionale, empatico e non giudicante è il primo passo per iniziare a prendersi cura di Sé.
Puoi contattarmi per chiedere informazioni o fissare un appuntamento, stabiliremo insieme come proseguire e, se Tu deciderai, inizieremo un percorso personalizzato, nel quale sarai parte attiva nel processo di ricerca del tuo benessere fisico, psicologico e relazionale.